SmaniaRock by Roberto
La discoteca di cineSmania
2020

Have a good trip, have Rock!
rubrica a cura di Roberto Gaudenzi
𝐋𝐄𝐃 𝐙𝐄𝐏𝐏𝐄𝐋𝐈𝐍 𝐈𝐕
𝐋𝐞𝐝 𝐙𝐞𝐩𝐩𝐞𝐥𝐢𝐧 (𝟏𝟗𝟕𝟏)
𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒'𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑤ℎ𝑜'𝑠 𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑔𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑙𝑑
𝐴𝑛𝑑 𝑠ℎ𝑒'𝑠 𝑏𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑖𝑟𝑤𝑎𝑦 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛
𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑠ℎ𝑒 𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑠ℎ𝑒 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑠, 𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑
𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑠ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑡 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑠ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑒 𝑓𝑜𝑟
𝑂𝑜ℎ, 𝑜𝑜ℎ, 𝑎𝑛𝑑 𝑠ℎ𝑒'𝑠 𝑏𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑖𝑟𝑤𝑎𝑦 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛
Ricordi?
Quanto ci ha incantato quel riff pesante, quel Black Dog, Umore Nero, che partiva dopo l’esplosione della voce di Plant che “a cappella” richiamava la nostra attenzione: “Hey hey mama said the way you move/gonna make you sweat, gonna make you move”. Non un canto ma frasi lanciate con veemenza e un senso vagamente erotico sottinteso, a noi piaceva la voce dal potente falsetto di Plant e quel riff micidiale. Erano i primi Led Zeppelin che ascoltavamo ma loro erano già al quarto album, da qui avremmo risalito la corrente per sapere cosa era venuto prima. Comunque niente come Black Dog perché i Led Zeppelin non si ripetevano e comunque quel pezzo ci è rimasto fuso nei timpani e sarebbe diventato una sorta di jingle.
Ricordi?
Fiero dell’acquisto aprivamo la copertina del disco dove su un muro sbrecciato pende un quadro con un vecchio curvo appoggiato a un bastone sotto il carico di una fascina di legna, si vedono palazzi di la dal muro, una periferia urbana: non ci sono scritte. E poi l’interno! L’interno della copertina ci spiazzava perché dovevamo guardarla verticalmente, tutta aperta, e in cima a una rupe a picco su un paesaggio gotico, un vecchio saggio incappucciato regge una lanterna e guarda in basso.
Ecco il nero umore che tinge in monocromia quel paesaggio misterioso e il suo osservatore silenzioso.
E poi arrivava 𝐑𝐨𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐨𝐥𝐥, e il disco prendeva fuoco. Già il titolo è un emblema: ““𝑓𝑎𝑚𝑚𝑖 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑟𝑒, 𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜, 𝑓𝑎𝑚𝑚𝑖 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑔𝑜”, sembra strano ma vi è già della nostalgia in un pezzo come questo, è rock and roll puro ma con una timbrica e un feeling mai sentiti prima. Il ritmo è serrato, Bonham dà subito il via ma la chitarra sembra frenare, allunga gli accordi, sembra tirare indietro come il testo suggerisce, soltanto nell’assolo si concede una breve corsa e la voce di Plant eccheggia dalle lontananze del tempo.
Ricordi che incuriositi sentivamo giungere da lontano e crescere note di mandolino e ci chiedevamo ma questi che arrivano dopo un pezzo scatenato chi sono? Si sentiva un sapore di folk, la voce di Plant duttile quanto mai... però ascoltando con attenzione non era lo stesso timbro, qualcuno lo accompagna, una voce femminile: Sandy Denny: già cantante dei Fairport Convention band di folk-rock, morirà nel ’78 a soli 31 anni. Plant ha un falsetto tale da distinguerlo a fatica dalla voce squillante di lei. 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐦𝐨𝐫𝐞, L’eterna battaglia, la guerra perenne tra il bene e il male, tra la luce e il buio. Riferimenti folkloristici, epica arturiana evocata con un accenno ad Avalon la mitica isola di re Artù e a leggere attentamente già si
poteva scorgere accenni al Signore degli Anelli di Tolkien. Folklore celtico, rune come antichi graffiti: qui in questo disco convivono anime diverse, in tre brani siamo passati attraverso tre umori distinti: un Hard Rock dalle tinte dark, un ritorno alle origini con un Rock and Roll classico e qui sapori acustici di altri tempi.
Ma la meraviglia che in una pozione alchemica mescola e amalgama tutto questo arriva con quell’inconfondibile arpeggio di chitarra acustica e una misteriosa “𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑒̀ 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑜̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑐𝑖𝑐𝑎 𝑒̀ 𝑜𝑟𝑜”: 𝐒𝐭𝐚𝐢𝐫𝐰𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐇𝐞𝐚𝐯𝐞𝐧 ci lascia incantati con il suo crescendo e quel tema di flauto. Un testo enigmatico di sentieri che si biforcano, di parole che possono avere due significati, di un uccello che canta su un ramo e di pensieri sospetti. Intanto che la chitarra arpeggia e il flauto ricama la sua melodia. Tutto questo mi stupisce, canta Plant, e di un sentimento strano quando si guarda a ovest, dove il sole tramonta e dove sono dirette le anime dei morti. Frutto di una scrittura automatica la canzone si arricchisce di riferimenti favolistici, mitici, sostenuta da un’acustica lieve ma incisiva che si alimenta facendosi più elettrica: la ballata con un retrogusto folkloristico si trasforma un rock duro e vigoroso, Bonham incide il ritmo intervenendo con il suo drumming poderoso, Page imbraccia la sei corde elettrificata e noi ci prepariamo per la festa della regina di maggio: un accenno alla primavera dove apprendiamo che la scala della signora giace sul vento che sussurra. Page cuce con un assolo misurato l’ultima parte alle premesse che si alza di tono e declama strofe su un popolo che scende in strada con le ombre più lunghe delle anime a seguire la signora che continua a dimostrare che tutto può trasformarsi in oro. Una delle più belle canzoni di sempre si conclude invocando una speranza di ritorno al tutto per essere una roccia e non rotolare: facile gioco di parole con il Rock and Roll, o il Like a Rolling Stone Dylaniano, o forse accenno diretto in negativo al Rolling Stones?
Forse il disco sarebbe potuto finire qui, non ci saremmo aspettati niente di meglio ma 𝐌𝐢𝐬𝐭𝐲 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐇𝐨𝐩 ci portava avanti con uno di quei riff che potresti non toglierti dalle orecchie per tanto tempo, un Rock Blues robusto che narra di una persona smarrita che si aggira tra gente con i fiori nei capelli che ti offre roba, poliziotti che cercano di metterti in riga. Un testo che procede con versi lunghi, faticosi come chi si aggira tra ciò che non conosce e accumula sensazioni e pensieri e il giro di note prosegue scoccando note come frecce, scandisce un passo pesante. La montagna nebbiosa è un rifugio dove vola lo spirito: la scala verso il cielo si tramuta in montagna.
Anche 𝐅𝐨𝐮𝐫 𝐒𝐭𝐢𝐜𝐤𝐬 è strutturata su un riff semplice dalle tonalità cupe: “𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑒 𝑖 𝑓𝑖𝑢𝑚𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑠𝑐𝑖𝑢𝑡𝑡𝑖?” Anche le tastiere che armonizzano il pezzo comunicano un senso di dramma incombente: “𝑐’𝑒̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑒...𝑠𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑣𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑡𝑒...𝑠𝑒 𝑖 𝑝𝑖𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑜 𝑎 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒...𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖?”
Così tornando ai climi di una ballata acustica 𝐆𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐨𝐫𝐧𝐢𝐚 stempera la tensione e riappacifica con colori malinconici. La California costante miraggio, eterna terra di confine dove l’estate dei figli dei fiori non si è ancora
del tutto spenta, limite ideale prima che il sogno svanisca del tutto, dove il tramonto che infuoca le sue sponde è prossimo a diventare simbolo di una fine permanente. “𝑇𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑟𝑒...𝑐𝑒𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑚𝑎𝑖 𝑛𝑎𝑡𝑎” . L’ideale prende consistenza in un amore impossibile: “𝑎𝑣𝑟𝑒𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑓𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒, 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎”. Ancora una collina, come in Misty Mountain Hop, un’altura su cui rifugiarsi: l’eremita dell’interno della copertina che guarda in basso con una lanterna in mano: Diogene che cerca l’uomo.
Ma incombe un pericolo che la batteria apre come preludio duro e crudo e ancora un riff e l’armonica blues che ricama un imminente disastro. 𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐞 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐬 incombe come un destino. La diga che rischia di crollare se continuerà a piovere: una chitarra che urla e il giro di note che ci ricorda l’imminenza del disastro. “𝑃𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑡𝑖 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑒𝑟𝑎̀, 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑡𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎̀ 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑜. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑖 𝑟𝑜𝑚𝑝𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑖 𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒”.
Ricordi?
I Led Zeppelin erano nel novero delle tre band che hanno inventato l’Hard Rock con i Deep Purple e i Black Sabbath. Loro si inserivano tra i due colorandosi di tinte folk acustiche. A differenza degli altri due che hanno lasciato il solco per futuri eredi, i Led Zeppelin forse hanno avuto meno epigoni, forse nessuno perché l’originalità del loro sound rischia di identificare ogni loro successore come un puro imitatore.
Ricordi chi sono?
Come non saperlo!
𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐭 – voce principale, tamburello, armonica a bocca (traccia 8)
𝐉𝐢𝐦𝐦𝐲 𝐏𝐚𝐠𝐞 – chitarra elettrica, chitarra folk, pedal steel guitar, cori, mandolino (traccia 3)
𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐉𝐨𝐧𝐞𝐬 – basso, EMS VCS3, flauti dolci, mellotron, organo, pianoforte, pianoforte elettrico, cori, chitarra folk (traccia 3), mandolino (traccia 7)
𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐁𝐨𝐧𝐡𝐚𝐦 – batteria, timpani, cori.
foto e articolo di © Roberto Gaudenzi - 18 dicembre 2020

𝟖 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟏𝟗𝟖𝟎
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒'𝑠 𝑛𝑜 ℎ𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛
𝐼𝑡'𝑠 𝑒𝑎𝑠𝑦 𝑖𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑡𝑟𝑦
𝑁𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤 𝑢𝑠
𝐴𝑏𝑜𝑣𝑒 𝑢𝑠 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑠𝑘𝑦
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒'𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑖𝑒𝑠
𝐼𝑡 𝑖𝑠𝑛'𝑡 ℎ𝑎𝑟𝑑 𝑡𝑜 𝑑𝑜
𝑁𝑜𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑘𝑖𝑙𝑙 𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑒 𝑓𝑜𝑟
𝐴𝑛𝑑 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑜
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑎𝑐𝑒, 𝑦𝑜𝑢
𝑌𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑦 𝑠𝑎𝑦 𝐼'𝑚 𝑎 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑒𝑟
𝐵𝑢𝑡 𝐼'𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑜𝑛𝑒
𝐼 ℎ𝑜𝑝𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑦𝑜𝑢'𝑙𝑙 𝑗𝑜𝑖𝑛 𝑢𝑠
𝐴𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑎𝑠 𝑜𝑛𝑒
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
𝐼 𝑤𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛
𝑁𝑜 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑑 𝑜𝑟 ℎ𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟
𝐴 𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑜𝑓 𝑚𝑎𝑛
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑, 𝑦𝑜𝑢
𝑌𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑦 𝑠𝑎𝑦 𝐼'𝑚 𝑎 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑒𝑟
𝐵𝑢𝑡 𝐼'𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑜𝑛𝑒
𝐼 ℎ𝑜𝑝𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑦𝑜𝑢'𝑙𝑙 𝑗𝑜𝑖𝑛 𝑢𝑠
𝐴𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑎𝑠 𝑜𝑛𝑒
Il Dakota building con l’ingresso sulla 72a strada ovest, offre una facciata su Central Park West la grande Avenue che costeggia l’omonimo parco dal lato occidentale e proprio all’ingresso del parco su quel lato un mosaico reca la scritta 𝐈𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞.
Chi ci aveva esortato ad immaginare un mondo senza paradiso, senza inferno, senza religioni e nessuno che per esse deva morire, un tragico e beffardo destino ha voluto che soccombesse proprio in modo violento, la stessa violenza che aveva sempre aborrito lo ha atteso al rientro a casa personificata da un pazzo mitomane e dalla bocca da fuoco di una pistola.
𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐋𝐞𝐧𝐧𝐨𝐧 si spegne di li a poco e con lui si spegne definitivamente un’epoca.
Con la sua morte vediamo sfumarsi in lontananza vent’anni e più che hanno assistito al nascere e l’evolversi di una musica che ha rinnovato i nostri ascolti. Dopo la storia continua, è chiaro, ma con una maturità diversa. Lennon è stato uno dei pionieri che ha dato vita ad un gruppo che ha contribuito a dare una spallata ai nostri gusti musicali, e la sua tragica e assurda fine sancisce la dissoluzione definitiva dei Beatles.
Scioltisi dieci anni prima, i quattro di Liverpool, come da molti erano e sono conosciuti, avevano rimescolato le sette note ognuno a modo loro nelle rispettive carriere soliste e ormai a due lustri di distanza una riunione era impensabile anche se ogni tanto veniva ventilata da qualcuno a corto di argomenti musicali. Lo stesso Lennon assolutamente considerava assurda solo l’ipotesi un ricompattamento del quartetto, giudicandolo inutile, anacronistico e soprattutto per giovare a chi? I Beatles avevano detto, per ciò che li riguardava, tutto ciò che c’era da dire: perché tornare assieme? Per qualche nostalgico? Per suonare per chi allora non c’era? I Beatles appartenevano alla storia e la storia non si ripete.
Tuttavia, anche se si era consapevoli che una reunion dei quattro era impossibile, pure il loro fantasma aleggiava all’intorno; con la morte di Lennon si è avuta la certezza che ormai ogni sia pure velleitaria speranza si dissolveva definitivamente: ora si era sicuri che i Beatles assieme, sia pure soltanto per realizzare un servizio fotografico, per essere intervistati coralmente e rinverdire la domanda sciocca di un loro ritorno, veniva a esalare l’ultimo respiro con colui che era stato con McCartney il plasmatore della magia.
E la magia si concretizza nel brano di apertura del secondo album solista di Lennon dopo lo scioglimento della band: 𝐈𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 che dà il titolo al disco del 1971.
A mio parere una delle canzoni più belle di sempre, anche perché costruita con una semplicità disarmante: un pianoforte vellutato che ripete un giro di accordi, che culla l’ascoltatore e lo accompagna in un viaggio anarcoide dove si immagina un mondo senza strutture. Interviene una sezione di archi me è lontana e come dissipata nella nebbia, una foschia leggera che sa di utopia, che vela nella distanza il mondo immaginato in una manciata di versi.
A mio parere una delle canzoni più belle di sempre, anche perché costruita con una semplicità disarmante: un pianoforte vellutato che ripete un giro di accordi, che culla l’ascoltatore e lo accompagna in un viaggio anarcoide dove si immagina un mondo senza strutture. Interviene una sezione di archi me è lontana e come dissipata nella nebbia, una foschia leggera che sa di utopia, che vela nella distanza il mondo immaginato in una manciata di versi.
“𝑃𝑢𝑜𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒, 𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑜.”
Puoi farlo, te lo concedo e so che hai ragione, in fondo, ma il sogno deve proseguire, infatti la parola più ripetuta nel testo è proprio il titolo: Immagina. Immaginare è un verbo che ha costruito storie da quando esiste l’umanità e nel mondo immaginato da Lennon nella canzone, così privo di tensioni, così libero da strutture, forse verrebbe a mancare il materiale necessario per costruire storie, per immaginare appunto.
Puoi farlo, te lo concedo e so che hai ragione, in fondo, ma il sogno deve proseguire, infatti la parola più ripetuta nel testo è proprio il titolo: Immagina. Immaginare è un verbo che ha costruito storie da quando esiste l’umanità e nel mondo immaginato da Lennon nella canzone, così privo di tensioni, così libero da strutture, forse verrebbe a mancare il materiale necessario per costruire storie, per immaginare appunto.
“𝐼𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑖 𝑠𝑖𝑎 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑠𝑜, 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑖𝑙 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜 𝑒 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑛𝑜”.
Subito Lennon spoglia completamente l’universo umano di ogni mito, sopra esiste solo il cielo, la visione non è più impedita da artificiali costruzioni teoriche, i cieli mobili delle visioni medievali, del paradiso dantesco; sembra anche suggerire un allontanamento dalla stessa osservazione scientifica.
“𝐼𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑜𝑔𝑔𝑖”.
Non c’è una visione di futuro, forse neppure memoria, infatti
“𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑖𝑟𝑒 𝑒 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒”.
La canzone si nutre delle sue stesse contraddizioni: se non vi è nulla per cui combattere, confini da difendere, viene a mancare anche il concetto di Storia, quindi di racconto, di immaginazione.
Lennon qui ci ha disarmati, ci fa vagare nella bruma del nulla, nel vuoto: perché se privi l’uomo di ciò che lo rende uomo, cosa resta? “Immagina nessun possesso”, forse la cosa più difficile da pensare: possiamo fare a meno di molte cose ma privarci di quanto possediamo è molto difficile. I detrattori qui hanno buon gioco: proprio uno come lui predica il “non possesso” lui che occupa tre appartamenti nel più esclusivo palazzo di New York? Lui che nuota nei soldi? Critica applicabile ad un numero svariato di categorie umane, ad istituzioni ma che non danneggiano lo spirito che le sostiene e che non prenderò in considerazione.
Qui c’è un mondo bianco come un foglio da scrivere. Siamo oltre i mondi immaginari teorizzati da Campanella da Tommaso Moro che pure prevedevano una struttura: qui non siamo più nella “Città del Sole” teorizzata dal primo o nel mondo di “Utopia” teorizzato dal secondo, qui siamo ai primordi, al Big Bang, al brodo primordiale in cui si è crogiolata la vita.
Canzone densa di negazioni, privativa, fa una tabula rasa di ciò di cui si nutre l’umanità, nel bene e nel male, in ultima analisi una canzone che annulla se stessa.
Che Lennon all’epoca avesse voluto suggerire un nichilismo conseguente alla rottura dei Beatles? Vi erano dissapori tra lui e McCartney, l’altro pilastro dei quattro, che aveva citato i compagni in tribunale e a cui è dedicata una sarcastica canzone dell’album. Capita che ragioni molto prosaiche diano il “la” per scrivere cose che trascendono la pura contingenza.
Mark David Chapman all’ingresso del Dakota Building attese il rientro di John Lennon, al quale aveva chiesto l’autografo quattro ore prima, e della moglie Yoko Ono, lo chiamò per nome per attirare la sua attenzione e gli esplose cinque colpi di pistola quattro dei quali andarono a segno.
“𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑠ℎ𝑜𝑡...”, ebbe il tempo di mormorare, “𝑚𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜...”.
Questo successe alle 22:52, alle 23:15 Lennon venne dichiarato morto. Venti minuti durante i quali non sapremo mai a cosa avesse pensato, ma forse non fece in tempo a pensare a nulla: un proiettile colpì l’aorta e la morte fu quasi istantanea.
Come un fermo immagine tragico, uno scatto che congela un istante, vedo Chapman con in mano una pistola fumante leggere “𝐼𝑙 𝐺𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑒𝑛”, il romanzo di Salinger che portava con sé, indifferente, in attesa della polizia; Yoko Ono terrorizzata che forse guarda il suo uomo sanguinante a terra, o forse l’assassino con una domanda muta negli occhi e John che in quel momento realizza che il mondo di Imagine può esistere solo se si raggiunge la condizione in cui si trova.
foto e articolo di © Roberto Gaudenzi - 8 dicembre 2020

𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄 𝐄𝐗𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒
𝐊𝐫𝐚𝐟𝐭𝐰𝐞𝐫𝐤 (𝟏𝟗𝟕𝟕)
𝐴 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑝𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑙𝑙 𝑜𝑓 𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠
𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒 ℎ𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 ℎ𝑖𝑚𝑠𝑒𝑙𝑓 .
𝑆𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑤 ℎ𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑒
𝐴𝑛𝑑 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑡 ℎ𝑖𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒
𝐻𝑒 𝑓𝑒𝑙𝑙 𝑖𝑛 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 ℎ𝑖𝑚𝑠𝑒𝑙𝑓
𝐴𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑑𝑑𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑
𝐸𝑣𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠
𝐷𝑖𝑠𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑚𝑠𝑒𝑙𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠
𝐻𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑢𝑝 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒
𝐴𝑛𝑑 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑛𝑒𝑤 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦
𝑇ℎ𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡 𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟
𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑐ℎ𝑜𝑒𝑠 𝑜𝑓 ℎ𝑖𝑚𝑠𝑒𝑙𝑓
𝐸𝑣𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠
𝐹𝑖𝑥 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠
𝐸𝑣𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠
𝐹𝑖𝑥 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠
(𝑇ℎ𝑒 𝐻𝑎𝑙𝑙 𝑜𝑓 𝑀𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠)
Può un treno che attraversa l’Europa essere il motore che trascina un’esperienza musicale? Certo, può. Se quattro tipi tedeschi dall’aria rigida, fredda, si mettono a smanettare sugli strumenti che la tecnologia mette a disposizione: generatori di frequenze, moog, sintetizzatori sono al servizio di questi signori che in essi si immedesimano al punto da trasformarsi in macchine programmate, automi dotati di creatività ma può la creatività essere caratteristica di un automa? Diremmo di no e allora i 𝐊𝐫𝐚𝐟𝐭𝐰𝐞𝐫𝐤 diventano una provocazione, un ironico distacco dalla tecnologia che nel tentativo di piegarla ai propri voleri ne vengono assorbiti, ne diventano parte integrante.
𝐑𝐚𝐥𝐟 𝐇𝐮̈𝐭𝐭𝐞𝐫 - voce, tastiere, sintetizzatori, sequencer, vocoder, effetti sonori.
𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐧𝐞𝐢𝐝𝐞𝐫 - sintetizzatori, sequencer, effetti sonori, voce, vocoder.
𝐊𝐚𝐫𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐨𝐬 - sintetizzatori, percussioni elettroniche, effetti sonori.
𝐖𝐨𝐥𝐟𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐅𝐥𝐮̈𝐫 - percussioni elettroniche.
I Kraftwerk sono i loro suoni sequenziati, i loro generatori di ritmo che sostituiscono alle pelli dei tamburi e al suono cristallino dei piatti, transistor e circuiti integrati, scorrere di elettroni su piste di circuiti stampati. La musica si è alimentata negli ultimi cinquant’anni di elettricità, il rock non è quasi concepibile senza strumenti elettrificati. E allora il nome della band è azzeccatissino: Kraftwerk, in italiano centrale elettrica.
Se si toglie l’energia elettrica non è pensabile nessuna esecuzione dal vivo e tanto meno l’ascolto da casa. L’estetica di tutta la musica che abbiamo trattato e che tratteremo (salvo qualche eccezione) è possibile grazie alla produzione forzata di energia: ma tutti gli artisti hanno usato l’energia (elettrica ed elettronica) non ne sono stati usati: i Kraftwerk ne sembrano asserviti, essi stessi hanno subito una mutazione trasformandosi in energia stessa, in circuiti programmati: hanno amalgamato loro stessi alla loro estetica, direi quasi che si sono fatti suonare.
Ogni nota, diremmo ogni frequenza qui vede oscillare il DNA umano. Ogni suono qui sembra generato con la fredda consapevolezza di portare con sé un po’ di genoma umano e restituirlo in una ripetitività automatica, discioglierlo in graffianti cumuli di accordi.
Ogni nota, diremmo ogni frequenza qui vede oscillare il DNA umano. Ogni suono qui sembra generato con la fredda consapevolezza di portare con sé un po’ di genoma umano e restituirlo in una ripetitività automatica, discioglierlo in graffianti cumuli di accordi.
I testi non sembrano canzoni ma citazioni, cartelloni pubblicitari, slogan di una società alienata nella 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬𝐬, l’infinita Europa la vita è infinita, si divide tra “𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒” 𝑡𝑟𝑎 “𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎”, in “𝑝𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖, 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙𝑠 𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑧𝑧𝑖” “𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖”, arrivano dopo una lunga introduzione a cavallo di una melodia leggera e metallica che sposa l’elettronica ad un Pop raffinato, scintillante: siamo lungo strade ricche di luminarie, vetrine luccicanti, viali di una città infinita “𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒”, ecco la parola magica: decadenza che ci riporta ai primi anni del secolo scorso, quando l’Europa così infinita sarebbe precipitata nel baratro della prima guerra mondiale.
Infatti un gioco di specchi rimanda immagini distorte dove le “stelle” intese come figure del divismo si innamorano della propria immagine. Con un tema molto meno rassicurante del precedente, 𝐓𝐡𝐞 𝐇𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐌𝐢𝐫𝐫𝐨𝐫𝐬 ripropone il mito di Narciso per la società moderna con la differenza che ora ognuno ha la possibilità di costruire la propria immagine e di cambiarla all’occorrenza ricevendo come soluzione un rispecchiamento continuo, straniante: “𝐿’𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜”, il ruolo dell’artista si frammenta in rimandi di immagine, l’artista come creatore vive in uno specchio e deve ogni poco ritrovare la sua vera immagine. Un rimprovero allo star system che spersonalizza, l’artista come emblema dell’uomo moderno che sembra avanzare nel brano con passo lento e pesante riprodotto dal battito in sottofondo che lo accompagna fino alla fine. Il tema che torna è come allucinato, fisso ad un orizzonte irraggiungibile perché perduto in mille riflessi.
In questa Europa senza fine, fatta di luccicanti richiami ci si riduce a 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐃𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞𝐬, manichini da vetrina, corpi in esposizione, fatti per essere guardati. Immediatamente introdotti con un tema che si sposta su e giù di un’ottava su un battere implacabile e echi sullo sfondo. Ma c’è un tentativo di ribellione quando i manichini decidono di muoversi e rompono la vetrina, escono per la città, entrano in una sala da ballo e iniziano a danzare, sembra non esserci via d’uscita se non manifestare se stessi nel ballo, nel corpo che si muove e che esprime la propria indipendenza; nella danza i manichini diventano umani, l’anima del movimento li scuote. Anche se tutto questo prende corpo in una musica prigioniera dei propri accordi che si scioglie in variazioni per rientrare nella gabbia di ritmi allucinati e melodie meccaniche, voci distorte e prive di emotività. I Kraftwerk si presentano come macchine, androidi asserviti ad una coscienza che li ha programmati.
Poi arriva con accordi in crescendo il 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬: signori in carrozza in una corsa annunciata da voci metalliche: un recitato che è un annuncio: sarà una corsa di 14 minuti divisa in tre parti da cui non c’è scampo, senza stazioni intermedie. Lasciamo Parigi in mattinata: è una fuga ma sembra di essere su un convoglio di deportati con un tema che si propone ad intervalli con praticamente impercettibili variazioni. Una macchina che corre inesorabile su binari che apparentemente attraversano il nostro continente, in pratica ci mostrano una società disumanizzata che corre non si sa dove come la scena musicale dell’epoca che vedeva esplodere il Punk e la grande storia che portava verso la fine di un decennio straordinario e violento. Il testo, impersonale come un annuncio, dice di una sosta a Vienna in un caffè notturno poi “𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒” (𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 titolo dell’album di 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐁𝐨𝐰𝐢𝐞 pubblicato l’anno precedente) accenna ad un incontro a Dusseldorf (sede degli studi dove registravano i Kraftwerk) con Bowie appunto e Iggy Pop. Sembra quasi di percepire qui l’odore di fuliggine tipico dei treni tanto è concreta e realistica la ricostruzione sintetica della corsa di un convoglio, sembra quasi di essere cullati dalle giunture dei binari che a ritmici intervalli passano sotto le ruote. Fintanto che il convoglio con stridore di freni si ferma...e non sappiamo dove siamo finiti, quale stazione è la nostra destinazione: sappiamo che il viaggio non ha offerto grandi paesaggi, non ha attraversato luoghi ameni e anche i passaggi nelle città nominate non ci hanno mostrato le loro bellezze, abbiamo solo viaggiato in una lunga galleria.
𝐅𝐫𝐚𝐧𝐳 𝐒𝐜𝐡𝐮𝐛𝐞𝐫𝐭 con il riferimento al compositore austriaco ci rimanda idealmente nel periodo romantico. Su un loop ritmico prendono vita cluster di accordi che sembrano rimbalzare come echi, perdersi svolazzanti su un paesaggio primaverile e sbiadito con un cielo pieno di nubi sfilacciate foriere di pioggia da cui filtrano sporadici raggi di sole. Il tutto sfuma nelle voci filtrate, metalliche, robotizzate che recitano Endless, senza fine, a riprendere il brano di apertura.
La musica di avanguardia si colora di popolarità e trasforma un suono di élite in qualcosa di più fruibile ma pur sempre attento alla ricerca. I Kraftwerk costruiscono composizioni minimaliste, spoglie, monocromatiche, tenute su timbri e sfumature di colore blu elettrico..
foto e articolo di © Roberto Gaudenzi - 4 dicembre 2020

CLIC
𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚𝐭𝐨 (𝟏𝟗𝟕𝟒)
𝑃𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒
𝑀𝑒 𝑒 𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎̀
𝐼𝑜 ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑜
𝐹𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠𝑐𝑒
𝐶𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑜
𝑃𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒
𝑉𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎̀
𝐻𝑜 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑡𝑜
𝑆𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀
𝐻𝑜 𝑑𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑖𝑟𝑒
𝐵𝑢𝑡𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖 𝑚𝑖𝑒𝑖 𝑚𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑎
𝑆𝑢 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑧𝑜𝑓𝑟𝑒𝑛𝑖𝑎
(𝑁𝑜 𝑈 𝑇𝑢𝑟𝑛 - 𝐹. 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎𝑡𝑜).
Scordiamoci il Battiato che verrà più avanti, il Battiato che costruisce canzoni, il più conosciuto, il più venduto (ovviamente), il più accattivante, il Battiato melodicamente strutturato, e avventuriamoci in quello elettronico, digitale, sperimentale, forse ironico, che ci meraviglia con sintetizzatori, strumenti i più disparati, dimentichiamoci per un po’ l’idea classica e canonica di musica, saltiamo al suo quarto album. 𝐂𝐋𝐈𝐂.
Lo scatto di un interruttore, il suono che dovrebbe accendere dei circuiti mentali diversi, tortuosi forse ma affascinanti; labirinti tra gangli neurali: qui non si balla, non si canticchiano melodie, si è immersi in quanto di meno commerciale possa esserci in ambito musicale. D’altronde non è una novità assoluta, lo è per l’Italia perché oltre le Alpi in quella Germania elettronica che ci ha fornito l’impropriamente detto 𝑲𝒓𝒂𝒖𝒕-𝑹𝒐𝒄𝒌 già band avanguardistiche come i 𝑪𝒂𝒏, , Can, i 𝑵𝒆𝒖, i 𝑭𝒂𝒖𝒔𝒕 solo per citarne alcuni, si sono cimentati in universi musicali paralleli, e lo stesso Battiato ha esordito con cose tutt’altro che di maniera.
Cose sorprendenti, collage musicali, recitativi, andando a pescare in altri territori, combinando melodie conosciute. Quello spirito libero di Gaber gli diede lo slancio e propose di accorciare il suo nome in Franco (invece di Francesco) per non essere confuso con l’allora nastro nascente Guccini. Ma Battiato con il cantautore ha poco da spartire e meno ancora lo si può confondere.
Con il Battiato di Clic si scende nelle profondità di noi stessi, nelle viscere della terra: suoni eterei, un sax gracchiante che entra a disturbare cacciato via da note di pianoforte poi un Sequencer che entra a rendere solido il tutto con il suo giro cupo. E’ un tappeto sonoro, una galassia che ruota compiendo un giro non in milioni di anni ma in pochi minuti: il tempo astronomico accelerato. 𝐈 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 si aprono davanti a noi e ci mostrano la nostra casa comune, quell’inconscio contenitore collettivo dove accumuliamo scorie, frammenti. Battiato sembra suggerirci questo, molta musica elettronica lo fa: pochi anni prima era la psichedelia, i 𝐏𝐢𝐧𝐤 𝐅𝐥𝐨𝐲𝐝 prima maniera ad esplorare il nascosto e lo facevano a colori vivaci, tinte rutilanti, caleidoscopi abbacinanti; l’elettronica ci ha insegnato ad essere più meditativi, la discesa nell’inconscio avviene con lunghi respiri, ad occhi chiusi.
Non c’è possibilità, non per ora, non mentre percorri questa strada, di tornare indietro: 𝐍𝐨 𝐔 𝐓𝐮𝐫𝐧, nessuna inversione di marcia, devi proseguire lungo questa direzione. Qui si intromettono suoni estranei, lamiere percosse e la voce che recita un testo rovesciato (non è un caso) che il prezioso libro di 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐙𝐮𝐟𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢 su Battiato (Battiato La Voce del Padrone ed. arcana 2018) ci informa essere evocativo di scene di solitudine cittadina con un rimprovero ad un innominato ministro. Un ritmo sequenziato prende piede sull’unico pezzo cantato che intona stati d’animo: “𝑓𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠𝑐𝑒...𝑠𝑢 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑧𝑜𝑓𝑟𝑒𝑛𝑖𝑎” una follia che si risolve musicalmente in ripetitive sequenze sonore, ossessioni di note e toni.
Ritorna la suggestione tedesca nel successivo 𝐈𝐥 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐃𝐞𝐢: i teutonici 𝐏𝐨𝐩𝐨𝐥 𝐕𝐮𝐡 echeggiano con delicate melodie di piano su tappeti sonori riprendendo un po' l’atmosfera del primo pezzo.
Passi, frinire di cicale, qualcuno che si ferma per svuotare la vescica e abbaiare di cani con un suono cupo in sottofondo a suggerire un paesaggio notturno; buio e note sparse di piano. Poi i passi riprendono e si ode lo squillo di un campanello, una porta si apre, note di trombone, una voce che sussurra, un battere di mani su motivi accennati, un maestro che scandisce il tempo su note di piano, gente che ridacchia su note di archi e un vociare come di accompagnamento al crescere degli accordi fino a giungere ad un accenno al 𝐕𝐚𝐥𝐳𝐞𝐫 𝐨𝐩. 𝟔𝟒 𝐧.𝟏 𝐢𝐧 𝐑𝐞 𝐛𝐞𝐦𝐨𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐡𝐨𝐩𝐢𝐧, al termine il suono secco di qualcosa che si chiude: il coperchio della tastiera del piano.
E’ un collage 𝐑𝐢𝐞𝐧 𝐧𝐞 𝐯𝐚 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 𝐀𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞, che ho cercato di descrivere ma che andrebbe vissuto come la breve sequenza di un film dove la componente mancante è lo sguardo fisico, concreto, che andrebbe sostituito dall’occhio della mente, e questo vale per tutto l’album e penso possa valere per ogni composizione di questo genere.
L’esperienza di questo ascolto richiede un passo ulteriore rispetto a ciò che abitualmente intendiamo per musica: qui le immagini (non a caso parlo di immagini, qualcosa di figurativo) si fanno più vive e non così astratte ed evanescenti come in un classico brano di musica.
La sigla della trasmissione 𝐭𝐠𝟐 𝐃𝐨𝐬𝐬𝐢𝐞𝐫 fa di 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐝𝐚 orse l’unico pezzo conosciuto ai più del disco. Su un tappeto cupo e distorto si snodano campiture sonore come pennellate elettroniche, i sintetizzatori sanno tingere la musica di colori ora vibranti ora opachi fino ad introdursi una sequenza ritmica doppiata da un oboe su cui si sovrappone un violino, sfuma il tutto per riprendere l’onda sonora che ha aperto il pezzo. Un piccolo gioiello elettronico che impreziosisce di sfumature un album già ricco di suggestioni e riferimenti.
Nel 𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧’𝐈𝐧𝐟𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚 ci introduce nei meandri dei ricordi, un cunicolo dove udiamo voci infantili, echi, vociferare incomprensibile e onde sonore che riverberano da lontano, una sorta di scansione di slogan introduce un intervento di mandole fino a sfumare in un’onda sonora. Le voci infantili sono anche queste in reverse e apprendiamo sempre dal prezioso volume di 𝐙𝐮𝐟𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢 (che ha potuto ascoltarle nella giusta “direzione”) che vengono pronunciate frasi al limite dell’assurdo. Ovviamente far capire il senso delle frasi non era nelle intenzioni di Battiato (altrimenti perché registrarle a rovescio?) e qui penso che interessasse il suono delle voci, il loro contrappuntare con le armonie elettroniche.
Il sintonizzarsi di una radio e un tema che apprendiamo essere il segnale dell’intervallo di radio Bucarest, poi una ricerca di frequenze dove udiamo suoni che sanno di Arabia, canti popolari, l’intrufolarsi di un frammento di una canzone del 1937 di 𝐍𝐢𝐧𝐨 𝐅𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚, Scrivimi, “𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑢 𝑠𝑒𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎, 𝑚𝑖 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑠𝑎" cantata da un concorrente della Corrida, (popolare trasmissione radiofonica di dilettanti allo sbaraglio, ripresa in anni più recenti dalla tv) poi il recitare di un radio dramma con l’attore che ostenta un forte accento inglese, poi voci e una cornamusa, interventi del 𝐷𝑢𝑐𝑒, il discorso della 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑛𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑎𝑣𝑜𝑖𝑎 sulla marcia trionfale dell’𝐴𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑖 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑖 finché la voce di Battiato ci augura la buonanotte seguita dall’inno nazionale che sfuma in una nota dissonante.
E’ 𝐄𝐭𝐡𝐢𝐤𝐚 𝐅𝐨𝐧 𝐄𝐭𝐡𝐢𝐜𝐚, un collage sonoro, frammenti di sintonia che ha come predecessore 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐂𝐚𝐠𝐞 che con 𝐒𝐭𝐨𝐜𝐤𝐡𝐚𝐮𝐬𝐞𝐧, 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠, 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐨𝐤 sono tra gli autori di musica contemporanea che vengono sovente citati come riferimenti.
Anche in questo caso ovviamente non si deve cercare un’esperienza esclusivamente musicale ma oserei dire totale: il pezzo scorre nelle nostre orecchie e ci si presenta agli occhi della mente come uno spezzone di pellicola della durata di quasi 4 minuti ed è come uno scorrere di pensieri senza trama, lampi e suggerimenti. Una radio che si sintonizza presuppone in fondo una ricerca: forse è questo che voleva fare il Battiato dell’epoca, dirci che dobbiamo guardarci attorno prima di trovare la giusta sintonia: lui lo stava facendo.
foto e articolo di © Roberto Gaudenzi - 27 novembre 2020

𝐑𝐀𝐃𝐈𝐂𝐈
𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐆𝐮𝐜𝐜𝐢𝐧𝐢 (𝟏𝟗𝟕𝟐)
Tempo fa con un amico si parlava di cantautori e ho dovuto confessare quanto il mio orecchio fosse a digiuno in questo campo. Dylan è stato il mio faro, poi Neil Young, Joni Mitchell, Nick Drake. ...E italiani? Il mio imbarazzo è stato notevole: ascolti saltuari, cose qua e là. Accidenti mi sono detto: un Nobel lo ha pur vinto un cantautore! E il cantautorato è pure un genere musical-letterario che merita grande attenzione. Attenzione che mi riprometto di dedicare d’ora in poi, per colmare lacune, per approfondire ascolti distratti.
Voglio iniziare con un album che mi porto dietro dalla scuola, e che da
tempo non ascoltavo, un disco italiano, di quello che forse è il re dei cantautori italiani (e qui già compio un’eresia: non De Andrè) parlo di 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐆𝐮𝐜𝐜𝐢𝐧𝐢 che nel 1972 esce con il suo quarto 33 giri: 𝐑𝐀𝐃𝐈𝐂𝐈.
Guccini all’epoca ha 32 anni, ma sembra che l’età delle illusioni giovanili per lui sia già finita. La copertina, in un antico color seppia, ritrae un’austera famiglia contadina, un gruppo di avi, radici appunto, come se già ci fosse nel nostro una maturità tale da fargli volgere indietro il capo per recuperare nella saggezza degli avi suggerimenti che la pienezza disillusa del tempo vissuto
non gli consente più di trovare.
Così “𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖” siede “𝑠𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑎”, dice Guccini, ed è sempre la stessa: una pietra antica che tace o forse pronuncia “𝑠𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑎”. Guccini porta con sé il senso antico degli antenati, volge indietro lo sguardo, oscilla il pensiero e la canzone è un altalenare di possibilità, perplessità, domande senza risposta ma che giungono alla conclusione che trasforma la casa in un "𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎”, una sede per le proprie radici, una fonte di saggezza.
𝐋𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐚, uno scarno classico accompagnamento di chitarra e la voce chiara e scandita ci narrano di un anarchico ferroviere che si lancia con una locomotiva “𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟𝑖”. La giustizia proletaria che si precipita contro un convoglio per compiere una strage, sembra prefigurare la violenza di sinistra che nel decennio di fuoco ha manifestato per le piazze. Unica canzone di colore nettamente politico della raccolta, vede una macchina “𝑚𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜” lanciata contro coloro che quel progresso hanno alimentato a scapito del sudore di tanti lavoratori, un gesto estremo che si ritorce contro chi lo mette in atto. Non penso che Guccini approvasse una strage e quindi la canzone è da leggere come metafora di una forza “𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡𝑎 𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑙’𝑖𝑛𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎”: la locomotiva verrà deviata su un binario morto dove troverà la distruzione e la morte del suo conducente.
Stupisce forse che Guccini abbia voluto inserire una canzone così spiccatamente militante in un album che trova la sua forza in una certa intimità di temi, dove una malinconia non tanto velata sembra fare il paio con un senso di perdita, forse di rammarico. Ma a ben vedere c’è qui anche una ricerca di senso e dunque la locomotiva cerca la strada in una idea di giustizia che seppure sbagliata nei metodi resta valida nelle intenzioni
Una ricerca di significato che si ferma di fronte all’oceano, sulle riflessioni della 𝐂𝐚𝐧𝐳𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨𝐠𝐡𝐞𝐬𝐞 contro “𝑙’𝑜𝑟𝑔𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑐𝑖𝑒𝑐𝑜” di chi conosce “𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑒”. Canzone divisa in due diverse sfumature musicali: una sorta di invettiva nella prima parte con il cantato che prende l’avvio “a cappella”, senza accompagnamento. “𝐸 𝑝𝑜𝑖, 𝑒 𝑝𝑜𝑖...” un avverbio ripetuto come se fossimo nel mezzo di un discorso già avviato, che presuppone qualcosa che stava prima, un cicaleccio, una confusione di verità, “𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑒”, “𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑓𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑎 𝑐ℎ𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒” . In mezzo a tutto questo la Bambina Portoghese è sola di fronte all’oceano, senza parole, “𝑟𝑢𝑚𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑣𝑜𝑐𝑖 𝑠𝑜𝑟𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒”, anche le voci degli amici vicino vengono sommerse dalla voce del mare: le parole inutili si zittiscono davanti ai suoni primordiali e alla consapevolezza di essere “𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒”. La bambina nel caldo del sole svanisce, di lei resta il bikini amaranto ed il mare. Guccini non ci dice che ne è di lei, il poeta che è in lui ci lascia sospesi come la bambina nel suo stupore: di lei resta la consapevolezza della velocità delle stagioni, di “𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑡𝑖 𝑢𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎̀” che “𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑓𝑢𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑜 𝑏𝑒𝑟𝑒”ma qualcosa che ci portiamo dentro, che è connaturato in noi e che è vivere.
Tra amarezza e rimpianto, 𝐏𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ (Modena) si muove tra amore e odio, “𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑖 𝑛𝑒𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖 𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑒𝑟𝑖”: una presenza ingombrante, diroccata nel dopoguerra, ricca di amori adolescenziali e voci e profumi. Ma Guccini vede il passato come “𝑠𝑐𝑖𝑜𝑐𝑐𝑎 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎”, una “𝑠𝑡𝑢𝑝𝑖𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎” che corre “𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎, 𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑎 𝐸𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 𝑒 𝑖𝑙 𝑊𝑒𝑠𝑡”; la pianura emiliana si trasforma in uno spazio sconfinato che consuma un “𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜”. Tra queste vie prendono forma suoni e odori e tutto sembra stare stretto: “𝑝𝑖𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟𝑒, 𝑖𝑙 𝑡𝑢𝑜 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜”: mestizia per la giovinezza andata, liberazione dalle catapecchie, dalle pietre, dalle liti e la miseria.
E' una filastrocca 𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐧𝐳𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐃𝐨𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐌𝐞𝐬𝐢 arricchita di colori che dipingono i mesi dell’anno declamati dalla voce seria e accigliata,
inconfondibile con la erre francese, di questo signore che dalla Osteria delle Dame di Modena dava i suoi spettacoli dal vivo tra un fiasco di vino e l’altro. Tempo che passa “𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑚𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑢𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑎𝑟𝑜𝑐𝑐ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑟𝑒”. Ma Guccini sapeva quale mano giocare e ha scelto le carte del poeta che si accompagna con scarni arrangiamenti e sembra dirci che non lontano si scopre il mondo, non in un west falso e costruito c’è un altrove ma dentro noi stessi, nelle nostre radici appunto risiede il mondo che ci appartiene: nella “𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀, 𝑏𝑎𝑠𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜”, nella “𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑎” oppure nell’incontro con un amore finito dove una coppia si rivede dopo anni circondata dalla nebbia, tra macchine ferme, nell’immobilità, nel silenzio di frasi non dette, tra “𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑣𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖 𝑚𝑢𝑟𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑔𝑜𝑛𝑜 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑖 𝑒𝑟𝑜𝑖” : bozzetti che descrivono magistralmente un ambiente, che immergono i due protagonisti in un’atmosfera che rispecchia le loro malinconie. Dove “𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑖 𝑐𝑖 𝑎𝑣𝑣𝑜𝑙𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑙𝑒” che restituisce un’immagine vischiosa che avviluppa nel dolce-amaro di una sostanza, il miele, che fa il paio con un sentimento umano non rappresentabile se non attraverso immagini. Ed è qui la forza evocativa di questo album: nell’incontro tra immagini ora focalizzate, “𝑠𝑡𝑜𝑣𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑔𝑖𝑎” e le aperture oceaniche sul confine di un continente, tra la via Emilia e il West.
𝐈𝐥 𝐕𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐞 𝐢𝐥 𝐁𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐨 mette a confronto generazioni su uno scenario di catastrofe. Un sintetizzatore apre il pezzo più struggente dell’album, un’ocarina fa da introduzione a una coppia che vediamo di spalle incontro alla sera e una polvere rossa in un’immensa pianura, e torri di fumo. Ci viene presentato qui uno spettacolo di distruzione che oltre al senso letterale di una reale catastrofe nucleare che all’epoca disturbava i sogni di molti, si legge la metafora della vecchiaia a cui sono stati rubati i sogni e che può solo osservare spettacoli di desolazione. Ma malgrado questo il bambino richiede altre storie, esorta il vecchio, in chiusura della canzone, a raccontarne altre come per rinnovare nel racconto la vita che in quel paesaggio è spenta.
Raccontare per restare in vita è il tema portante delle Mille e una Notte, la raccolta di storie orientale dove la narratrice Sharazade racconta storie per ritardare la sentenza di morte che pende su di lei. Forse Guccini ha voluto intendere questo, un narratore, e un cantautore prima che musicista è un narratore, crea storie per la sopravvivenza.
foto e articolo di © Roberto Gaudenzi - 20 novembre 2020

𝐈𝐍 𝐎𝐆𝐍𝐈 𝐋𝐔𝐎𝐆𝐎
𝐅𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞 (1999)
“𝑆𝑢 𝑐𝑖𝑜̀ 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑒̀ 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟𝑒, 𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑒”
(𝐿𝑢𝑑𝑤𝑖𝑔 𝑊𝑖𝑡𝑡𝑔𝑒𝑛𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛)
Guardate la copertina di questo album: un giovane profilo coperto da una maschera di creta asciutta, secca, venata di crepe come un terreno arido e il nome della band scritto in corsivo. Potrebbe sbriciolarsi quella pelle, vorrebbe apparire vecchia ma è solo una maschera; oppure è lo sgretolarsi dell’involucro di una crisalide? Ma forse è una statua che prende vita, o una vita che si sta solidificando in una statua. In ogni luogo, ovunque la si consideri potrebbe richiamare un significato.
Spesso mi sono domandato: quali sono i personali criteri che mi fanno dire “questo disco mi piace e questo no”? Me lo sono chiesto ascoltando 𝐈𝐧 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨, terzo album del 1999 dei 𝐅𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞, gruppo italiano di Genova attivo dal 1993 con quattro album in studio e due dal vivo dal 1994 al 2004 e che si sono ritrovati in studio nel 2019 per riincidere il loro primo disco nel 25° anniversario della sua uscita.
Loro sono: 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐥𝐥𝐢 (chitarra, voce), 𝐁𝐨𝐫𝐢𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞 (tastiere), 𝐀𝐠𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐜𝐨𝐫 (tastiere), 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐙𝐮𝐟𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢 (basso), 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐎𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 (batteria); ospiti: 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐋𝐚𝐠𝐨 (voce), 𝐄𝐝𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐨 (fiati), 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐨 (strumenti a corda).
Dicevo dei criteri, non li saprei definire se non con termini impressionistici, per così dire. Sovente si parla di colore della musica, di gusto musicale, ma sono termini che coinvolgono una diversa sede sensoriale che non è l’udito: quindi potremmo dire che l’ascolto è l’operazione che maggiormente coinvolge i sensi, attraverso l’udito passano messaggi che suscitano inevitabilmente una risposta ampia e variegata. Questo mi succede per tutto ciò che ascolto e credo che succeda a ognuno di noi. Inoltre la musica è un’arte la cui fruizione è dinamica: è lei che guida l’ascoltatore attraverso una linea temporale e detta il tempo di ascolto, in questo senso è come il cinema. Per un’opera letteraria è il lettore che detta il ritmo con la sua velocità di lettura; un’opera figurativa è statica, si lascia guardare, non ha la dinamicità di fruizione di una sequenza di note o dello scorrere di fotogrammi, si lascia per così dire girare attorno, ha un certo grado di passività, mentre l’ascolto di un pezzo musicale esige che tu ti metta al suo passo, certo puoi fermarti su ogni nota ma non sarebbe più la stessa cosa. In ogni caso lo riascolti e può accadere che il coinvolgimento dei sensi vada in un’altra direzione, sovente evoca sensazioni indefinite, inafferrabili.
Finisterre con questo disco quasi totalmente strumentale, hanno portato sensorialmente a pomeriggi tiepidi di primavera, assolati, hanno portato in quel luogo che il loro nome richiama, Finisterre: località della Spagna, nella Galizia dove apprendo esserci un faro che si affaccia sull’Atlantico, un faro
che pone fine alla strada del pellegrino verso Santiago di Compostela. La fine delle terre conosciute per l’antichità. Può ricordare anche la nostra S. Maria di Leuca, l’estrema punta del tacco italiano dove la terra finisce.
E il viaggio che parte con 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐢 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢 prende il via con echi e richiami, vedi figure avanzare da lontano, il passo si snoda veloce poi rallenta come a riprendere fiato, riparte. Il titolo porta alla mente il film di Chaplin, l’omino negli ingranaggi, tutt’uno la macchina, cinghia di trasmissione egli stesso.
E il cinema è presente ancora in 𝐒𝐧𝐚𝐩𝐨𝐫𝐚𝐳. Chi ha visto La Città delle Donne di F. Fellini sa che questo è il nome del protagonista della pellicola interpretato da Marcello Mastroianni e qui il testo del brano è costituito da dialoghi presi da La Dolce Vita, capolavoro del maestro che penso non abbia bisogno di presentazioni. Un omaggio al cinema, a Fellini che della settima arte è stato uno dei più originali rappresentanti e che Fish, ex cantante dei Marillion, nel 2001 omaggerà con il suo album solista intitolato al riminese, Fellini Days, riprendendo lo stilema trovato qui dai Finisterre di inserire dialoghi di film e interviste (era Fish a conoscenza di questo pezzo?)
I Finisterre ci sanno portare a 𝐍𝐢𝐧𝐢𝐯𝐞, antica città mesopotamica, ricca di storia, anche qui sotto un tiepido sole che rischiara antiche rovine, reperti risalenti a qualche migliaio di anni or sono. Suscitano con i titoli viaggi esotici e la coda di questo pezzo sa sollevare il velo del tempo con un paesaggio intravisto tremolante in un caldo medio oriente.
E infatti 𝐈𝐧 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨 che dà il titolo al disco trasforma il pomeriggio assolato in un “respiro lento” come recita il testo cantato dalla voce di Francesca Lago. Possiamo trovarci veramente ovunque qui tra luci e calde penombre, estenuati, “𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜”.
Sanno anche essere duri e scaldarti alla canicola i Finisterre, portarti dove il mare è un confine da ammirare e lì fermarsi attoniti ad ammirare l’orizzonte oppure tornare indietro di corsa. Poi ti arresti perché un segnale come un telegrafo impazzito si trasmette dal 𝐂𝐨𝐫𝐨 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨 e sospendi attonito il viaggio. Lo riprendi con echi orientaleggianti: forse l’Africa scaldata dal deserto attende con una danza dove un derviscio ruota senza fine.
Sanno anche essere duri e scaldarti alla canicola i Finisterre, portarti dove il mare è un confine da ammirare e lì fermarsi attoniti ad ammirare l’orizzonte oppure tornare indietro di corsa. Poi ti arresti perché un segnale come un telegrafo impazzito si trasmette dal 𝐂𝐨𝐫𝐨 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨 e sospendi attonito il viaggio. Lo riprendi con echi orientaleggianti: forse l’Africa scaldata dal deserto attende con una danza dove un derviscio ruota senza fine.
E riprendiamo il discorso fatto poc’anzi: 𝐀𝐠𝐥𝐢 𝐀𝐦𝐢𝐜𝐢 𝐒𝐢𝐧𝐞𝐬𝐭𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢 brano che richiama nel titolo l’interferenza sensoriale. Qui siamo sempre in ogni luogo come fossimo ubiqui, arpeggi come interrogazioni che sfociano in melodie leggere. Percepiamo anche l’accenno ad una marcetta conosciuta. Abbiamo il sole che inizia ad allungare le ombre sul finale, e 𝐏𝐞𝐭𝐞𝐫’𝐬 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 attende accogliente con umore rockeggiante su un tappeto uniforme fino ad aprire la porta per accoglierci.
Già il sole scende e davanti a noi sull’orizzonte striature rosse fluttuano sull’oceano. E’ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐭𝐚̀𝐝𝐢𝐥𝐚𝐫𝐚𝐧𝐞𝐥𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨, titolo senza soluzione di
continuità, appunto, che evoca tonalità calde con un retrogusto jazz da locale notturno fumoso. Torna la voce di Francesca Lago larga e dolente. Peter’s House è forse la taverna che accoglie il nostro peregrinare e ancora siamo attoniti, fermati da arpeggi che sbloccano una chitarra distorta in una coda melodica.
𝐖𝐢𝐭𝐭𝐠𝐞𝐧𝐬𝐭𝐞𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐧 𝐀𝐦𝐨𝐮𝐫 chiude con un omaggio all’autore del Tractatus logico-philosophicus affidando al suono baritonale di uno strumento a fiato una melodia quasi come una ninna nanna adulta, ripetuta senza variazioni, davanti ad un sole già ridotto a un semicerchio sull’orizzonte infuocato. Forse ora ho la risposta alla mia domanda iniziale: quali sono i criteri che mi guidano e mi fanno dire, questa musica mi piace? Quando nei timpani entrano sequenze di note che sollecitano la mente, dove tutti i sensi convergono e creano immagini, sapori, sensazioni.
E i Finisterre ci riescono..
foto e articolo di © Roberto Gaudenzi - 13 novembre 2020

𝐏𝐀𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐎𝐍
𝐎𝐩𝐞𝐭𝐡 (2014)
𝐴𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑛
𝐴 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑 𝑜𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛
𝐴𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑔ℎ𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛 𝑚𝑦 ℎ𝑒𝑎𝑑
𝐻𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑚𝑒
𝐿𝑖𝑓𝑡𝑒𝑑 ℎ𝑖𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒 𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑚𝑒
(𝐹𝑎𝑖𝑡ℎ 𝑖𝑛 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 )
Gli 𝐎𝐩𝐞𝐭𝐡 sono svedesi, si sono formati a Stoccolma nel 1990 e nel 1995 registrano il loro primo album Orchid. Nascono come band di Death Metal ma la loro evoluzione è stata continua, Steven Wilson nel 2001 ci ha messo lo zampino e una band già con caratteristiche proprie e distinguibili decolla definitivamente.
Nel 2014 arriviamo a questo 𝐏𝐚𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧, loro undicesimo album, la Comunione Pallida, e certo che per una banda di death metal non è male intitolare un disco al pallore post vita che ci accoglie in un unico destino.
𝑂𝑝𝑒𝑡 è la mitica “𝐶𝑖𝑡𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑎” di un romanzo di Wilbur Smith del 1972 da cui la band ha tratto il proprio nome aggiungendo una H, e Opet è anche festa sacra egiziana dedicata al dio Amon: sembra che il mito voglia essere già la cifra della band che qui sembra rivelarsi già dall’inizio con 𝑬𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 𝑹𝒂𝒊𝒏𝒔 𝑾𝒊𝒍𝒍 𝑪𝒐𝒎𝒆.
Scenderanno piogge eterne, il mito del diluvio distruttore, il castigo divino che scende incessante con un’intro movimentata che crea confusione e sgomento, poi si appiana riflessiva, una pausa nello scrosciare incessante nella ricerca del tema che entra con una chitarra delicata per sciogliersi in un organo che ci accerchia.
“𝑉𝑒𝑟𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑙𝑒 𝑝𝑖𝑜𝑔𝑔𝑒 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒...𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑟𝑎̀ 𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑐𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒”
Una chiara visione catastrofica, che non offre riparo e che da una band di death metal ci potremmo aspettare risolta in un sound estremo, brutale: invece abbiamo qui una voce sdoppiata quasi dolente, un tono generale che sembra accettare l’ineluttabile: “𝑑𝑜𝑣𝑟𝑒𝑚𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑜 𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑓𝑟𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖... 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒𝑣𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑖𝑜̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑟𝑎”.
Uno sguardo indietro fa accettare l’ora presente.
Decolla con una ritmica molto heavy 𝑪𝒖𝒔𝒑 𝒐𝒇 𝒆𝒕𝒆𝒓𝒏𝒊𝒕𝒚 e si mantiene su un basso pulsante mitigato solo da un coro vocale come un’invocazione che separa le strofe. Una bambina nata in autunno in un mondo di inganni e di morte e in una terra di ghiaccio...attraversa il paese e tiene la testa alta sotto la pioggia. Viene al mondo qualcuno nel diluvio e un tono epico pervade il pezzo. Una madre si guarda indietro, una scena della sua memoria. Ancora è presente lo sguardo al passato; l’attesa di una chiamata che la porti al culmine dell’eternità sembra qui essere il motivo di consolazione.
Si tiene in equilibrio tra cupezze e momenti lirici, introspettivi 𝑴𝒐𝒐𝒏 𝑨𝒃𝒐𝒗𝒆, 𝑺𝒖𝒏 𝑩𝒆𝒍𝒐𝒘: la luna in alto e il sole in basso, il pezzo più lungo, una notte continua, il sole c’è ma si trova nel punto basso, “𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑐𝑜 𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒” perennemente immersi nel buio. Oscilla il sound tra altezze e profondità come se in questo scorcio di ventunesimo secolo fosse difficile arrancare: “𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑖 𝑟𝑖𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑒̀ 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑏𝑎”.
Cupezza di maniera? Una posa da “metallari” dove il tema d’oltretomba diventa un pretesto per fare colpo? Direi di no, non colgo indulgenze e autocompiacimenti ma il proseguire dolce amaro verso una meta irrevocabile. “𝑁𝑜𝑛 𝑐’𝑒̀ 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒. 𝑁𝑜𝑛 𝑐’𝑒̀ 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑜, 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑖 𝑠𝑖 𝑎𝑔𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑎 𝑢𝑛 𝑓𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑚𝑎. 𝑁𝑜𝑛 𝑐’𝑒̀ 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑜, 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑐ℎ𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎”.
Solo cerchi nell’acqua viene reiterato fino al termine del brano: un sommovimento che si appiana per tornare quello che era: uno sconvolgimento senza risultati. Sembra una resa alla sorte, una inutilità di lotta: si può solo sconvolgere una superficie calma ma non si giunge a nulla.
Una ballata semi acustica, 𝑬𝒍𝒚𝒔𝒊𝒂𝒏 𝑾𝒐𝒆𝒔, che ci porta in uno strano luogo mitologico che affianca il termine “woes” guai, calamità, alla parola Elisi che dovrebbe evocare i campi dove venivano accolte le anime amate dagli dei. Si capovolge qui la mitologia e diventa un luogo di guai, problemi: “𝐸 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑐’𝑒̀ 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝑎𝑔𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑠𝑖”. Sugli arpeggi di chitarra sostenuti da un tappeto evocativo di tastiere, prendono corpo domande senza risposta: stiamo assistendo alla distruzione? Ci si domanda se l’intenzione era seguire una strada fino alla fine anche se la fine era un mondo di dolore. “𝑁𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑛𝑢𝑑𝑜 𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑒”: le ferite devono restare nascoste, la canzone evoca un pudore che sembra prendere corpo nel brano successivo lo strumentale 𝑮𝒐𝒃𝒍𝒊𝒏 che reitera un riff come se fosse indeciso, come un balbettio che tenta di esprimersi e ritorna su se stesso per interrompersi improvviso.
𝑹𝒊𝒗𝒆𝒓 prosegue il discorso di Elisyan Woes: una ballata acustica che si risolve però in un tono più movimentato sul finale con riff serrati e ricami chitarristici. Si apre come una canzone d’amore ma troviamo corpi che galleggiano sul fiume verso oceani di morte. Tutte le cose verranno annullate: quindi perché disperarsi? Arriva un momento in cui il fiume si prosciuga. Arriva l’inverno che sacrificherà le nostre vite. Nel fluire degli assolo scorre un fiume in secca.
Con incedere cupo e un vago sapore orientale la nebbia dorme sull’acqua e l’inverno si nasconde nei cuori, il tradimento della mente e dell’anima, l’eco di un fallimento e l’amore è un fantasma che ride: 𝑽𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝑻𝒓𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏. Il brano sembra prendere una consistenza disperata che si espande in tre interrogativi declamati a tutta voce: “𝐻𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒? 𝑆𝑒𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑢𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜? 𝐻𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖?" Poi la musica scende e il mellotron espande tappeti evocativi che richiamano altre domande: “𝐶𝑖 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑖? 𝐸’ 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎? 𝑇𝑖 𝑠𝑒𝑖 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑜? 𝐿’𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑖 𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑜 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑒?”
Su questi punti interrogativi il brano si spegne sfumando su note di piano, poi come un grande respiro emerge dal profondo un mellotron che potrebbe richiamare le larghe vedute dei King Crimson dei primi tempi. Alla rabbia segue una quieta disperazione evocata dalle tastiere: senza soluzione di continuità emerge 𝑭𝒂𝒊𝒕𝒉 𝒊𝒏 𝑶𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 a chiudere in bellezza il disco, cresce e
cattura una solenne orchestra che stende un tema come un tappeto: “𝐿𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑖𝑛𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑒̀ 𝑖𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎... 𝑐𝑖 𝑚𝑢𝑜𝑣𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑒”, si girano pietre per trovarvi delle prove ma tutto si nasconde nei recessi dei nostri cuori. Poche note di piano accompagnano un cantato con un sussurro represso: “𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖𝑜”.
Prende piede un secondo tema sulla sei corde, poi un vocalizzo dolente sembra emergere da freddi recessi finché una voce che sembra già giungere dall’aldilà narra di avere attraversato lande squallide con un innato bisogno di possesso. Non c’è fede nella croce, tu cerchi di afferrare la mia mano ma è solo ghiaccio che si scioglie. La soluzione è tornare bambini: “𝑒 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑚𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑚𝑖 ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 ℎ𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑒𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑢 𝑑𝑖 𝑚𝑒.” Il tema dolente ci porta alla fine, ci accompagna come una ninna nanna, si scioglie nella certezza dell’innocenza.
𝐌𝐢𝐤𝐚𝐞𝐥 𝐀̊𝐤𝐞𝐫𝐟𝐞𝐥𝐝𝐭 (voce, chitarra, mellotron), 𝐅𝐫𝐞𝐝𝐫𝐢𝐤 𝐀̊𝐤𝐞𝐬𝐬𝐨𝐧 (chitarra) Martin 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳 (basso), 𝐉𝐨𝐚𝐤𝐢𝐦 𝐒𝐯𝐚𝐥𝐛𝐞𝐫𝐠 (mellotron, organo, pianoforte, tastiere), 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐀𝐱𝐞𝐧𝐫𝐨𝐭 (batteria, percussioni), danno vita a uno di quei dischi, a mio parere, da portare con sé in caso di naufragio e penso che in questo scorcio di millennio che ci costringe a rivedere stili di vita, a combattere contro un virus subdolo, in definitiva a proteggerci dai danni da noi provocati nei decenni trascorsi, meditare su quel “Pallido destino comune” sia necessario se non altro per esorcizzarne lo spettro; e guardare indietro soprattutto per recuperare se non tutta almeno parte dell’innocenza perduta.
foto e articolo di © Roberto Gaudenzi - 6 novembre 2020

𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐁𝐒𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐎𝐅 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐂𝐄
Kansas (2020)
𝑆𝑒𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒
𝐹𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
𝑆𝑒𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒
𝐿𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒
𝐺𝑖𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑚 𝑎 𝑓𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑇𝑜 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑
𝑆𝑒𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒
(𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒 - 𝐾𝑎𝑛𝑠𝑎𝑠)
Il Kansas è uno stato del midwest degli Stati Uniti d’America, sulla cartina è un rettangolo dai confini tracciati con una nettezza euclidea, è un’immensa tavola che occuperebbe due terzi della superficie italiana con poco meno di 3 milioni di abitanti. Nell’immaginario collettivo richiama pianure sconfinate dove pascolano bisonti e dove un tempo scorrazzavano i Sioux e dalla lingua di questa tribù deriva il nome: Kansa che significa “popolo del vento del sud”. Possiamo immaginarci strade come nastri che attraversano i campi e in certe stagioni dell’anno trombe d’aria che si attorcigliano sotto un cielo cupo, corrono a spirale e risucchiano ciò che incontrano con qualche temerario fotografo che dà loro la caccia tra ranch sparsi qua e là. La capitale è Topeka e da qui provengono i membri fondatori della band che prenderà il nome dello stato.
I 𝐊𝐚𝐧𝐬𝐚𝐬 si formano nel lontano 1974. Da allora c’è chi è andato e chi si è aggregato. Della band originale rimangono il batterista e un chitarrista. Sono in sette: due tastieristi, tre chitarristi uno dei quali anche al violino, più sezione ritmica.
𝐏𝐡𝐢𝐥 𝐄𝐡𝐚𝐫𝐭 batteria dalla formazione originale; 𝐁𝐢𝐥𝐥𝐲 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐫 basso e voce; 𝐓𝐨𝐦 𝐁𝐫𝐢𝐬𝐥𝐢𝐧 tastiere; 𝐑𝐨𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐭 tastiere e voce; 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐑𝐚𝐠𝐬𝐝𝐚𝐥𝐞 violino, chitarra; 𝐙𝐚𝐤 𝐑𝐢𝐳𝐯𝐢 chitarra; 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦𝐬 chitarra dalla formazione originale.
Pur essendo d’oltre oceano la loro “cucina” ha un sapore 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒗𝒆 in una musica dove l’ingrediente principale sa di America profonda. La loro musica varia su strutture più complesse, cambi di tempo, melodie corali a più voci e una vena blues stemperata, disciolta.
Autori di 16 album in studio, 6 live più varie antologie, i Kansas hanno sfornato a gennaio di questo nefasto 2020 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐛𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞, un bell’ossimoro: l’assenza di una presenza“𝑠𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑠𝑒𝑖 𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑖 𝑑𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑖”, recita un verso del brano omonimo di apertura che si annuncia accennando un tema di violino dopo isolate note di piano, un ampio respiro su ritmi incisivi, tastiere a tratti evocative con interventi del violino che mi ricordano i 𝐁𝐢𝐠 𝐁𝐢𝐠 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧, grande band inglese con una spiccata vena folk.
Onore a questa band che sa iniettarsi dosi di modernità senza ripudiare il passato. 𝑻𝒉𝒓𝒐𝒘𝒊𝒏𝒈 𝑴𝒐𝒖𝒏𝒕𝒂𝒊𝒏 è decisamente hard con quel riff di chitarra ammorbidito dall’intervento sempre del violino.
Onore a questa band che sa iniettarsi dosi di modernità senza ripudiare il passato. 𝑻𝒉𝒓𝒐𝒘𝒊𝒏𝒈 𝑴𝒐𝒖𝒏𝒕𝒂𝒊𝒏 è decisamente hard con quel riff di chitarra ammorbidito dall’intervento sempre del violino.
Con un intro al pianoforte di sapore classico 𝑱𝒆𝒕𝒔 𝑶𝒗𝒆𝒓𝒉𝒆𝒂𝒅 vira verso il folk e 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒖𝒍𝒔𝒊𝒐𝒏 1 dà una spinta strumentale prima di 𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔 𝑫𝒐𝒘𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑳𝒊𝒏𝒆 una ballad con gusto anni ’80 e ancora quel rivolo folk che serpeggia
sempre.
“𝑆𝑝𝑒𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑠𝑢 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎
𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒...
𝑑𝑎𝑖 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒
𝑠𝑎𝑝𝑒𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑜”
Senza rammarico queste note rimarcano il valore dell’esperienza e i Kansas, anziani testimoni di un’epoca, in questa ballata lanciano un messaggio di speranza.
Nel circo dell’illusione siamo sotto un incantesimo. 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒍𝒆 𝒐𝒇 𝑰𝒍𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 sa trasportare all’interno di un tendone dove le fruste del domatore si rompono e i leoni vengono confinati in gabbia dopo essere saltati nel cerchio di fuoco. Prendendo le mosse da un tema evocatore il cantato sembra raccontare amichevolmente, il sound è sempre pieno, la musica sembra inciampare per trovare poi un equilibrio, una dimensione che viene riordinata dal tema che il violino ricama. Siamo sbalzati in un incantesimo dove si fatica a trovare un’uscita.
Tastiere convulse, un andamento ondivago, gli animali sul tetto sanno la verità, si distinguono dai tempi della loro giovinezza, non sono mai stati quelli che correvano con la folla. Cito liberamente il testo di 𝑨𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍𝒔 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑹𝒐𝒐𝒇 dove vi trovo una dichiarazione di indipendenza dalla massa informe che è la folla.
𝑵𝒆𝒗𝒆𝒓 volge lo sguardo indietro con un’altra ballad sulla scia di rimpianti che attempati signori si possono concedere senza tuttavia indulgere in autocommiserazioni. E’ usuale chiedersi se si fosse potuto fare diversamente, se in un universo parallelo le scelte non compiute avessero potuto torcere la nostra vita in un altro modo, ma c’è una volontà che accetta e spinge a cambiare, una tenace spinta a proseguire: “𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑎 𝑢𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑒.”
Brano con un breve preludio enfatico, 𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝑹𝒊𝒗𝒆𝒓 𝑺𝒂𝒏𝒈 sembra stilisticamente uscire dalla compattezza del resto del disco, si tende nella parte strumentale finale con una ritmica scandita a rimarcare una sorta di invettiva.
Sarò sincero: ho sempre ascoltato i Kansas sporadicamente, non sono mai stato un fan di quella corrente che è stata battezzata 𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐑𝐨𝐜𝐤: gruppi che fondono rock duro ma orecchiabile per riempire gli stadi e che noi, che cerchiamo in questo mondo musicale un respiro più ampio e libero e a cui la definizione di Rock inteso in senso stretto ci risulta limitante, abbiamo considerato con una sorta di snobismo. Ora, con il trascorrere degli anni, ci ricrediamo e apprezziamo uno stile che possiede una sua compattezza e che non è così stereotipato come ci sembrava..
foto e articolo di © Roberto Gaudenzi - 30 ottobre 2020

FAITH
The Cure (1981)
𝐶𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑚𝑒 𝑖𝑓 𝐼 𝑓𝑎𝑙𝑙, 𝐼'𝑚 𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑙𝑑
𝐼 𝑐𝑎𝑛'𝑡 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑤𝑎𝑦
𝐴𝑛𝑑 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝐼 𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑦
𝐼 𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑 𝑔𝑎𝑚𝑒
𝑇ℎ𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑠 𝑚𝑒
(𝑇ℎ𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑒 - 𝐹𝑎𝑖𝑡ℎ)
Torniamo a parlare dei 𝐂𝐮𝐫𝐞 con l’album successivo e in fondo parente stretto del precedente 𝐒𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞𝐞𝐧 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐬. Dal titolo della prima traccia e dell’ultima omonima, 𝐅𝐚𝐢𝐭𝐡, che esce nell’aprile del 1981, sembra racchiudere un processo religioso, stante il significato principale che il termine fede inevitabilmente evoca. Aggiungiamo poi il dichiarato proposito di Robert Smith di avere voluto ricreare un suono come se si fosse all’interno di una cattedrale ricco di echi ed evocativo di alte volte, navate e pareti riverberanti.
In questi tempi nefasti di pandemia una dose di fede se non religiosa, per lo meno intesa nell’accezione di fiducia verso le autorità scientifiche e perché no politiche, è necessaria, ma certo all’epoca queste cose erano ben lontane dall’essere immaginate.
I 17 secondi che nel disco precedente sono la misura della vita, il breve lasso di tempo sufficiente a cambiare il tuo essere, lasciano un vuoto che la fede o meglio, come ci piace più immaginare e come del resto i Cure intendono, la fiducia, contribuisce a colmare. Ma questa fiducia va conquistata, nel vuoto si impone una ricerca di senso. 𝑻𝒉𝒆 𝑯𝒐𝒍𝒚 𝑯𝒐𝒖𝒓 vorrebbe essere una ricerca di spiritualità trascendente: “𝑚𝑖 𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐ℎ𝑖𝑜 𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜....𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑡𝑒” il buio che già precedentemente era così spesso evocato, torna qui. ““𝑈𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑚𝑖 𝑓𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒”, i bambini giocano, torna l’infanzia ma la voce di chi prega è un pianto, un urlo senza parole che si rompe contro una pietra antica. L’inizio affidato al basso dà l’avvio a un tema largo e soffuso alle tastiere che sembra voler intraprendere un percorso interiore. Il brano termina con lugubri rintocchi funebri di campana che seguono la sincope della batteria che ha spento la scansione ritmica, precisa e sostenuta.
“𝑃𝑖𝑢̀ 𝑎𝑛𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜
𝑝𝑖𝑢̀ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑎𝑚𝑜
𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑠𝑎𝑝𝑝𝑖𝑎𝑚𝑜
𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑚𝑜”
ad un aumento corrisponde una sottrazione. Su un cantato che rincorre il tempo in 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒚 c’è la sorpresa dell’innocenza addormentata. Un viso appena intravisto e una musica a cui si cambia la melodia; un corpo appena sfiorato e un racconto che troppo in fretta giunge alla conclusione. Il brano ha un andamento nervoso, una rincorsa verso l’inevitabile decadimento.
Uno spazio pieno di echi, un basso che ripete in solitaria la stessa frase poi un urlo strozzato.
“𝑆𝑢𝑠𝑠𝑢𝑟𝑟𝑜 𝑖𝑙 𝑡𝑢𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑎”:
la vacuità sempre presente. Qui torna una vaga e vana ricerca di assoluto, un rumore lontano: 𝑶𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑽𝒐𝒊𝒄𝒆𝒔. Rumori e voci lontane dicono: “𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎, 𝑡𝑖 𝑠𝑏𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒”.
La ricerca di assoluto che in The Holy Our sembrava dissolversi in un limbo qui sembra concretizzarsi in un vuoto approccio rituale:
“𝑉𝑖𝑒𝑛𝑖 𝑖𝑛 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑎 𝑁𝑎𝑡𝑎𝑙𝑒...
𝑢𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜.”
In un ritmo circolare veniamo intrappolati nelle grotte dove una cupa melodia riecheggia rimbalzando su pareti irregolari. “𝑁𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑟𝑒𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑡𝑟𝑒.” 𝑨𝒍𝒍 𝑪𝒂𝒕𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝑮𝒓𝒆𝒚 è una discesa negli inferi dove Ade, divinità infernale, si presenta in un universo di pietra dove le “𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑢𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑟𝑚𝑖. 𝑁𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑐𝑎 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑠𝑐𝑢𝑟𝑖 𝑙𝑎𝑔ℎ𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑖”. 𝑁𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑔𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑔𝑟𝑖𝑔𝑖” ” non esiste più colore nell’Ade, tutto è indistinto, ““𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑜𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎”, tutto è scarnificato, forse chi canta è già morto rimane solo una voce lontana e quasi sussurrata. Termina il pezzo su cupe, isolate note di piano, come le campane funebri del pezzo di apertura.
Su un tappeto di tastiere 𝑻𝒉𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒚 procede come un lungo e mesto corteo, “𝑑𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑖𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑓𝑟𝑜𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜”. Non si sa di chi è il feretro perché non si tratta di un essere umano ma di marionette che si muovono senza passato in un teatrino, “...𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒.”
𝑫𝒐𝒖𝒃𝒕 è urlata, tagliente, crudele, in pochi minuti si consuma un femminicidio, un orribile assassinio. Se Killing an Arab mostrava un distaccato omicidio senza scopo, qui un odio feroce su scaglia su un altro essere. Il dubbio non porta alla stasi ma alla violenza, all’emissione del sangue.
I Cure in questo album compongono brani che intrappolano al loro interno, chiudono cerchi ritmici in cui la melodia echeggia, sorge e svanisce. La musica crea un recinto, ci racchiude in una cripta piena di melodie eteree e ritmi ossessivi dove la voce ora emerge dolente, ora quasi sussurra, ora urla angosciata dimostrando la duttilità vocale di Robert Smith.
Se Doubt sembra già prefigurare le invettive che saranno nel successivo Pornography, 𝑻𝒉𝒆 𝑫𝒓𝒐𝒘𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑴𝒂𝒏 torna alle atmosfere grigie che colorano tutto l’album: una chitarra disperde pochi accordi e il cantato è diviso su due canali come due istanze che si confrontano. L’acqua accoglie in un abbraccio mortale l’essere che “𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑢𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒” annaspa in mezzo all’oceano mentre una figura femminile si erge sopra al diluvio per affondare, mentre i suoi ricordi svaniscono. Una relazione finita male che lascia senza fiato, un battesimo che porta a fondo. Mi ha ricordato il finale di 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐞𝐧, capolavoro di 𝐉𝐚𝐜𝐤 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧, dove il protagonista mette fine ai suoi giorni spingendosi a fondo nel mare, annegando volontariamente perché svuotato di ogni desiderio e meta; e come dimenticare la tragica fine della fidanzata di Amleto, Ofelia annegata nel fiume.
𝑭𝒂𝒊𝒕𝒉 arriva nel finale e sembra un segno di speranza. “𝐴𝑓𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑜, 𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎...” ma subito dopo: “𝐿’𝑖𝑑𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒”, e poco più avanti: “Violentami come un bambino/battezzato nel sangue/ dipinto come un santo sconosciuto”, sembra non essere rimasto altro se non la fede in una ricerca disperata ma: “𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑎 𝑣𝑜𝑐𝑒 𝑒̀ 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑎.”“𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑙𝑜𝑤𝑛 𝑏𝑖𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒.” Non si accenna a religioni qui e in questa folla felice “𝑛𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖, 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖 𝑜𝑐𝑐ℎ𝑖, 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑎”. In The Funeral Party si accenna già nel titolo a incontri ludici in opposizione col luttuoso evento, e nel finale di Faith quel cantato dolente che recita: “𝑚𝑒 𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑑𝑎𝑖 𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑜, 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑑𝑒” sembra la chiusa del corteo che accompagna una bara vuota.
La copertina astratta, grigia, dove il retro corrisponde al negativo della parte frontale, sembra volere riprodurre una contraddizione, due diversi aspetti di una stessa idea. La fede qui non è una religione vuota ridotta ad un party, piuttosto un’idea laica di fiducia, di speranza.
I Cure in questo album sono in tre dopo la defezione del tastierista 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐡𝐢𝐞𝐮 𝐇𝐚𝐫𝐭𝐥𝐞𝐲 presente nel disco precedente e in tre resteranno anche nell’album successivo: 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐒𝐦𝐢𝐭𝐡 (chitarra voce e tastiere); 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐮𝐩 (basso); 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐓𝐨𝐥𝐡𝐮𝐫𝐬𝐭 (batteria).
foto e articolo di © Roberto Gaudenzi - 23 ottobre 2020

𝐂𝐀𝐍𝐓𝐄𝐑𝐁𝐔𝐑𝐘 𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚
𝑌𝑜𝑢 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑒
𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑎𝑚-𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑒
𝐼𝑡'𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑠ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑙𝑦 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑜𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑙𝑦 𝑓𝑖𝑠ℎ, 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑟𝑝𝑜𝑖𝑠𝑒, 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑙𝑦 𝑏𝑎𝑏𝑦 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚 𝑤ℎ𝑎𝑙𝑒
(𝑅𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡 𝑊𝑦𝑎𝑡𝑡 - 𝑆𝑒𝑎 𝑆𝑜𝑛𝑔)
(𝙻𝚊 𝚜𝚌𝚘𝚛𝚜𝚊 𝚟𝚘𝚕𝚝𝚊 𝚊𝚋𝚋𝚒𝚊𝚖𝚘 𝚕𝚊𝚜𝚌𝚒𝚊𝚝𝚘 𝚒 𝚍𝚞𝚎 𝚊𝚖𝚒𝚌𝚒 𝚙𝚛𝚘𝚜𝚜𝚒𝚖𝚒 𝚊𝚍 𝚊𝚟𝚟𝚒𝚌𝚒𝚗𝚊𝚛𝚎 𝚒𝚕 𝚜𝚒𝚐𝚗𝚘𝚛𝚎 𝚒𝚗 𝚌𝚊𝚛𝚛𝚘𝚣𝚣𝚎𝚕𝚕𝚊 𝚏𝚎𝚛𝚖𝚘 𝚜𝚞𝚕𝚕𝚊 𝚛𝚒𝚟𝚊 𝚍𝚎𝚕 𝚕𝚊𝚐𝚑𝚎𝚝𝚝𝚘 𝚒𝚗 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚎𝚖𝚙𝚕𝚊𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎. 𝙼𝚊 𝚞𝚗𝚘 𝚍𝚎𝚒 𝚍𝚞𝚎 𝚎̀ 𝚒𝚖𝚋𝚊𝚛𝚊𝚣𝚣𝚊𝚝𝚘, 𝚗𝚘𝚗 𝚟𝚘𝚛𝚛𝚎𝚋𝚋𝚎 𝚍𝚒𝚜𝚝𝚞𝚛𝚋𝚊𝚛𝚎 𝚚𝚞𝚎𝚕𝚕’𝚊𝚝𝚝𝚎𝚖𝚙𝚊𝚝𝚘 𝚎 𝚋𝚊𝚛𝚋𝚞𝚝𝚘 𝚜𝚒𝚐𝚗𝚘𝚛𝚎 𝚌𝚘𝚗 𝚍𝚘𝚖𝚊𝚗𝚍𝚎 𝚒𝚗𝚘𝚙𝚙𝚘𝚛𝚝𝚞𝚗𝚎, 𝚎 𝚜𝚝𝚛𝚊𝚝𝚝𝚘𝚗𝚊 𝚕’𝚊𝚕𝚝𝚛𝚘 𝚌𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚗 𝚜𝚕𝚊𝚗𝚌𝚒𝚘 𝚝𝚎𝚗𝚝𝚊 𝚍𝚒 𝚊𝚟𝚟𝚒𝚌𝚒𝚗𝚊𝚛𝚜𝚒.)
𝑵𝒐, 𝒅𝒂𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒎𝒊 𝒔𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂 𝒊𝒍 𝒄𝒂𝒔𝒐: 𝒏𝒆𝒑𝒑𝒖𝒓𝒆 𝒍𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒄𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒆 𝒐𝒓𝒂 𝒂𝒏𝒅𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒍𝒊̀ 𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒆𝒅𝒆𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒄𝒐𝒔𝒊̀, 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒔𝒆 𝒏𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒇𝒐𝒔𝒔𝒆.
Non ti devi preoccupare, stai tranquillo che non manderà via nessuno, io lo conosco.
𝑳𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒄𝒊? 𝑺𝒆𝒆𝒆...𝒅𝒂𝒊 𝒔𝒖𝒐𝒊 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊 𝒍𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒄𝒊.
Fidati, vieni, vedrai che non ti manderà a quel paese.
𝑵𝒆𝒍𝒍’𝒖𝒅𝒊𝒓𝒆 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒄𝒖𝒏𝒐 𝒂𝒗𝒗𝒊𝒄𝒊𝒏𝒂𝒓𝒔𝒊, “𝑨𝒍𝒇𝒊𝒆 𝒔𝒆𝒊 𝒕𝒖?” 𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒔𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒓𝒔𝒊 𝒊𝒍 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒐𝒓𝒆 𝒃𝒂𝒓𝒃𝒖𝒕𝒐 𝒆 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝒈𝒍𝒊 𝒂𝒏𝒏𝒊.
“𝑺𝒄𝒖𝒔𝒂𝒄𝒊 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕, 𝒕𝒊 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒂𝒎𝒐?”
𝑳’𝒖𝒐𝒎𝒐 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛𝒛𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒍’𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒊 𝒄𝒉𝒊 𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒐𝒗𝒓𝒂 𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒏𝒊 𝒆 𝒅𝒊𝒄𝒆: “𝑨𝒉 𝒔𝒆𝒊 𝒕𝒖? 𝑷𝒆𝒏𝒔𝒂𝒗𝒐 𝒇𝒐𝒔𝒔𝒆 𝒎𝒊𝒂 𝒎𝒐𝒈𝒍𝒊𝒆.
𝑨𝒍𝒍𝒐𝒓𝒂, 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒗𝒂?”
“𝑩𝒆𝒏𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒛𝒊𝒆, 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒕𝒖 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒃𝒆𝒏𝒆 𝒗𝒆𝒅𝒐.”
“𝑵𝒐𝒏 𝒎𝒊 𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐” 𝒊𝒍 𝒔𝒖𝒐 𝒔𝒐𝒓𝒓𝒊𝒔𝒐 𝒆̀ 𝒃𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐. “𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒂 𝒎𝒆𝒓𝒂𝒗𝒊𝒈𝒍𝒊𝒂𝒕𝒐 𝒆̀ 𝒖𝒏 𝒕𝒖𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒄𝒐? 𝑮𝒖𝒂𝒓𝒅𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒖𝒏 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒎𝒂....𝑳𝒐 𝒉𝒂𝒊 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒂𝒈𝒏𝒂?”
“𝑪𝒆𝒓𝒕𝒐, 𝒗𝒐𝒍𝒆𝒗𝒂 𝒂𝒔𝒄𝒐𝒍𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒂 𝒗𝒊𝒄𝒊𝒏𝒐 𝒊 𝒔𝒖𝒐𝒏𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒏𝒊𝒗𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒊, 𝒆̀ 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒂𝒍𝒂𝒎𝒊𝒕𝒂.”
“𝑫𝒊𝒓𝒆𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒆̀ 𝒓𝒊𝒎𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒓𝒊𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒊𝒑𝒏𝒐𝒕𝒊𝒛𝒛𝒂𝒕𝒐: 𝒔𝒄𝒉𝒊𝒐𝒄𝒄𝒂 𝒍𝒆 𝒅𝒊𝒕𝒂, 𝒇𝒂𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒄𝒐𝒔𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒗𝒆𝒈𝒍𝒊𝒂𝒓𝒍𝒐...”
“𝑺𝒂𝒊, 𝒗𝒐𝒍𝒆𝒗𝒂 𝒔𝒂𝒑𝒆𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒎𝒂𝒊, 𝒕𝒖 𝒃𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂, 𝒕𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒗𝒊...”
“𝑺𝒖 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒛𝒛𝒐 𝒅𝒊 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒐? 𝑫𝒊𝒈𝒍𝒊 𝒅𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒐𝒄𝒄𝒖𝒑𝒂𝒓𝒔𝒊, 𝒏𝒐𝒏 𝒗𝒐𝒈𝒍𝒊𝒐 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒓𝒍𝒐... 𝒔𝒖 𝒓𝒂𝒈𝒂𝒛𝒛𝒐, 𝒄𝒐𝒔𝒂 𝒕𝒊 𝒉𝒂 𝒅𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒒𝒖𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒕𝒊 𝒊𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆? 𝑺𝒆 𝒔𝒆𝒊 𝒄𝒐𝒔𝒊̀ 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐 𝒏𝒐𝒏 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒊𝒄𝒐.”
“𝑵𝒐 𝒏𝒐, 𝒍𝒂 𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒔𝒄𝒐𝒍𝒕𝒂𝒏𝒅𝒐!”
“𝑬 𝒍𝒂𝒔𝒄𝒊𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒍𝒆𝒊. 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒒𝒖𝒆...𝒆𝒓𝒐 𝒖𝒃𝒓𝒊𝒂𝒄𝒐, 𝒖𝒏𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒒𝒖𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒔𝒊𝒎𝒐 𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒓𝒊𝒐...𝒔𝒂𝒑𝒆𝒕𝒆 𝒂 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒄𝒖𝒏𝒐 𝒉𝒐 𝒅𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒔𝒊̀ 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒊 𝑺𝒐𝒇𝒕 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒆 𝒎𝒊 𝒂𝒗𝒆𝒗𝒂𝒏𝒐 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒕𝒂𝒕𝒐, 𝒄𝒐𝒔𝒊̀ 𝒊𝒐 𝒎𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒃𝒖𝒕𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒗𝒊𝒂. 𝑬𝒓𝒂𝒗𝒂𝒎𝒐 𝒂𝒅 𝒖𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒚 𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒂𝒑𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒎𝒊 𝒉𝒂 𝒕𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒔𝒊̀ 𝒍’𝒉𝒐 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒆 𝒎𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒕𝒓𝒐𝒗𝒂𝒕𝒐 𝒕𝒓𝒆 𝒑𝒊𝒂𝒏𝒊 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒔𝒐𝒕𝒕𝒐, 𝒔𝒖𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂. 𝑰 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊 𝒎𝒊 𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒆 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒂𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂 𝒗𝒊𝒗𝒐 𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒗𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒖𝒃𝒓𝒊𝒂𝒄𝒉𝒆𝒛𝒛𝒂: 𝒔𝒆 𝒎𝒊 𝒇𝒐𝒔𝒔𝒊 𝒊𝒓𝒓𝒊𝒈𝒊𝒅𝒊𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒅𝒖𝒕𝒂 𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕’𝒐𝒓𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒔𝒂𝒓𝒆𝒊 𝒒𝒖𝒊 𝒂 𝒓𝒂𝒄𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒓𝒍𝒐, 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒄𝒆 𝒒𝒖𝒂𝒔𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒎𝒊 𝒓𝒆𝒔𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒔𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒗𝒐 𝒇𝒂𝒄𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒆 𝒉𝒐 𝒕𝒐𝒄𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒔𝒖𝒐𝒍𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒖𝒏 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒐𝒄𝒄𝒊𝒐 𝒂𝒇𝒇𝒍𝒐𝒔𝒄𝒊𝒂𝒕𝒐.
Sai, questo signore da allora ha fatto un sacco di cose come solo lui avrebbe saputo fare. Per un po’ di anni ha fatto tutto da solo, si è attrezzato uno studio e tutto quanto, ha all’attivo centinaia di collaborazioni con altri musicisti: insomma non è mai stato un isolato, anzi. E’ stato impegnato anche politicamente....
𝑰𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒉𝒂 𝒅𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒉𝒂𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒊𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒊 𝒄𝒂𝒑𝒐𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒊.
Il tuo amico esagera. Ho suonato, l’unica cosa di cui mi vanto è avere orecchio.
Non devi dargli retta fino in fondo: 𝐑𝐨𝐜𝐤 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐨𝐦, 𝐎𝐥𝐝 𝐑𝐨𝐭𝐭𝐞𝐧𝐡𝐚𝐭, 𝐃𝐨𝐧𝐝𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧, 𝐒𝐡𝐥𝐞𝐞𝐩... sono solo alcuni dei dischi incisi a suo nome.
𝑬’ 𝒗𝒆𝒓𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒕𝒖𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂 𝒂𝒗𝒆𝒕𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒐𝒖𝒏𝒅?
Ecco un’altra favola. Ho detto non ricordo più a chi che a noi è successo come a quel pover’uomo morto in croce: è spirato senza essere stato consapevole di avere inventato il cristianesimo. Noi suonavamo quello che ci piaceva, ci sentivamo liberi di sperimentare, fondevamo rock and roll, jazz, blues, tutto quello che ascoltavamo, ma non ci siamo mai messi a tavolino per dire, ecco adesso facciamo il Canterbury Sound, anche perché molti neppure erano di Canterbury.
𝑺𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒛𝒐𝒏𝒆. 𝑬’ 𝒔𝒐𝒇𝒇𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒑𝒊𝒖𝒎𝒂...
Esatto, bella definizione. E’ 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐀𝐲𝐞𝐫𝐬 e la voce che senti cantare nel ritornello all’unisono è proprio il qui presente signor Wyatt. Se ricordi Ayers è presente nel primo disco dei Soft Machine ed è uno dei fondatori, ma se ne è andato presto e ha avuto una ottima carriera solista: un grande outsider, questo pezzo è da 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐡𝐞𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬𝐰𝐞𝐬𝐢𝐧𝐠...
𝑻𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒂𝒄𝒄𝒂𝒕𝒐!
Già come uno sciogli lingua. In lui c’è un rivolo di malinconica dolcezza che senti già nella voce e sperimentazione, stravaganze, ironia: un grande che non ha avuto l’attenzione che si meritava e che forse neppure l’ha cercata.
𝑬𝒑𝒑𝒖𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒍𝒐 𝒄𝒆𝒓𝒄𝒂𝒏𝒐 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊, 𝒎𝒊 𝒗𝒐𝒓𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒅𝒊𝒓𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒖𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒍𝒐 𝒉𝒂 𝒎𝒂𝒊 𝒄𝒆𝒓𝒄𝒂𝒕𝒐?
Tutto sta in che modo lo si cerca. Secondo me ci sono due vie, rimanendo se stessi o tradendo la propria visione di arte. Nessuno in questa scena penso abbia mai cercato un successo di vendite da classifica tradendosi. Ovviamente se il successo arriva nessuno lo butta via o lo rifiuta.
𝑨𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆́ 𝒔𝒖𝒐𝒏𝒂𝒗𝒂𝒎𝒐 𝒓𝒐𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒏 𝒑𝒐𝒄𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆. 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒊 𝒓𝒂𝒈𝒊𝒐𝒏𝒆: 𝒇𝒂𝒄𝒆𝒗𝒂𝒎𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒊 𝒑𝒊𝒂𝒄𝒆𝒗𝒂 𝒇𝒂𝒓𝒆.
𝑯𝒐 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊 𝒖𝒏𝒂 𝒔𝒐𝒓𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒊𝒔𝒕𝒊...𝒂𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒔𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒂𝒎𝒂? 𝑹𝒐𝒄𝒌 𝒊𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒄𝒐𝒔𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒓𝒅𝒐.
Rock in Opposition, bravo, ricordi bene e l’iniziativa vede musicisti che arrivano da qui, da questa terra in grigio e rosa.
Viene giusto a fagiolo con il nostro discorso: questi musicisti si oppongono infatti alle logiche commerciali delle grosse case discografiche da qui arrivano gli 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲 𝐂𝐨𝐰, dall’Italia gli 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐦𝐲 𝐒𝐢𝐱.
𝑳𝒂 𝑴𝒖𝒄𝒄𝒂 𝒅𝒊 𝑯𝒆𝒏𝒓𝒚 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒎𝒆 𝒄𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒐!
Già quelli con il calzettone sulla copertina dei primi loro dischi, quelli del chitarrista 𝐅𝐫𝐞𝐝 𝐅𝐫𝐢𝐭𝐡 e del batterista 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬 𝐂𝐮𝐭𝐥𝐞𝐫 è un ensemble che ha raggruppato a fasi alterne grossi nomi, anche 𝐌𝐢𝐤𝐞 𝐎𝐥𝐝𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝.
𝑸𝒖𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒊 𝐓𝐮𝐛𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐬?
Proprio lui, non era di queste parti ma lo spirito è tutto in questa regione dove uno può starsene su una carrozzella a contemplare il lago, e le colline. Tubular Bells, con quell’inizio come campanellini che hanno un sapore favolistico, e uno sviluppo che galleggia in questo cielo rosa, tutto acustico, uno svolazzare di uccellini, poi il sopraggiungere di un pericolo, forse un temporale cupo e minaccioso...
𝑯𝒆𝒊 𝒔𝒗𝒆𝒈𝒍𝒊𝒂𝒕𝒊! 𝑵𝒐𝒏 𝒔𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒒𝒖𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒅𝒊 𝑶𝒍𝒅𝒇𝒊𝒆𝒍𝒅!
Hai ragione, ma è tutto così bucolico.
𝑮𝒖𝒂𝒓𝒅𝒂 𝒄’𝒆̀ 𝒒𝒖𝒊 𝒖𝒏 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒍𝒆: 𝐇𝐚𝐭𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡, 𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒍𝒂̀ 𝒊𝒏 𝒄𝒊𝒎𝒂, 𝒔𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒂𝒎𝒂 𝒄𝒐𝒔𝒊̀ 𝒒𝒖𝒆𝒍 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐?
No, è un segnale che si trova fuori Londra e indica precisamente una località e il nord dell’Inghilterra, quel nome lo hanno preso in prestito i signori che stanno lassù.
𝑫𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒆𝒓𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊? 𝑭𝒐𝒓𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒊 𝒏𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊?
Direi né una cosa né l’altra, sono 𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 chitarrista già Caravan, Matching Mole; 𝐃𝐚𝐯𝐞 𝐒𝐭𝐞𝐰𝐚𝐫𝐭 alle tastiere; 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐒𝐢𝐧𝐜𝐥𝐚𝐢𝐫 al basso e voce dai Caravan; 𝐏𝐢𝐩 𝐏𝐲𝐥𝐞 batterista (Gong, Delivery) più altri amici collaboratori tra cui ovviamente 𝐖𝐲𝐚𝐭𝐭. E’ giusto che siano nel loro castello di magie, dominano dall’alto tutta la terra grigio e rosa, ne colgono l’essenza fatta di ironia, non-sense, leggero spleen, uno stile in punta di dita che aggiunge sfumature pastello a questa bicromia già ricca di per sé.
𝑾𝒚𝒂𝒕𝒕 𝒉𝒂 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒏𝒏𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒋𝒂𝒛𝒛.
Infatti da qui provengono i 𝐍𝐮𝐜𝐥𝐞𝐮𝐬 del trombettista 𝐈𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐫, i 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐢𝐩𝐞𝐝𝐞, 𝐊𝐞𝐢𝐭𝐡 𝐓𝐢𝐩𝐩𝐞𝐭𝐭, e molti altri. Qui il jazz si è svincolato un po’ dal classico swing, si è contaminato, loro sono figli del 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐬 di 𝐁𝐢𝐭𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐁𝐫𝐞𝐰 che ha aperto orizzonti vari.
𝑴𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒏𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒓𝒐𝒄𝒌!
Se con questo termine intendi chitarroni roboanti, assoli sfrenati, un ritmo riconoscibile e quasi ballabile allora no, non è rock. Ma se intendi musica aperta, ricca e non chiusa in se stessa, allora lo è.
“𝑰𝒐 𝒏𝒐𝒏 𝒉𝒐 𝒎𝒂𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒊𝒔𝒐 𝒖𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒊𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒐𝒄𝒌.”
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒊𝒆𝒏𝒆 𝑾𝒚𝒂𝒕𝒕 𝒄𝒉𝒆 𝒆𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕𝒐 𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒎𝒑𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒍𝒂𝒈𝒐.
Sentito? Qualcuno lo ha definito Progressive e secondo me è un termine azzeccato: qualcosa che progredisce, che non è mai statico, ripetitivo, che è alla ricerca di suoni nuovi, di stili nuovi.
𝑬𝒅 𝒆̀ 𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒊, 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒗𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒅𝒐.
No, non da qui ma qui ha avuto uno sviluppo direi quasi autonomo, riconoscibile, diverso.
Vieni, saliamo un poco lungo il sentiero che porta al castello, e lasciamo Robert alle sue contemplazioni.
𝑫𝒂 𝒒𝒖𝒂𝒔𝒔𝒖̀ 𝒔𝒊 𝒗𝒆𝒅𝒐𝒏𝒐 𝒂𝒍𝒕𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒆, 𝒂𝒍𝒕𝒓𝒆 𝒃𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒐𝒏𝒂𝒏𝒐.
Già, e sono in gran parte italiani, forse perché noi abbiamo assimilato lo spirito Progressive molto bene. Quelli laggiù sono i 𝐏𝐢𝐜𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐃𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐳𝐳𝐨, e là un poco oltre vedi i 𝐖𝐢𝐧𝐬𝐭𝐨𝐧𝐬, i 𝐌𝐨𝐨𝐠𝐠...
𝑪𝒐𝒎𝒆 𝒊𝒍 𝒔𝒊𝒏𝒕𝒆𝒕𝒊𝒛𝒛𝒂𝒕𝒐𝒓𝒆?
Quasi solo con una g in più. 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐙𝐮𝐟𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢, eclettico musicista e non solo, con numerose incarnazioni in gruppi e progetti vari. Sono artisti di ieri e di oggi che sarebbe lungo star qui ad elencare.
𝑬’ 𝒗𝒆𝒓𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒊𝒄𝒄𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂 𝒊𝒏 𝒈𝒓𝒊𝒈𝒊𝒐 𝒆 𝒓𝒐𝒔𝒂.
Puoi dirlo! Tra parentesi sai che David Sinclair, il bassista e voce dei Caravan e degli Hatfield and the North, vive in Italia? In Puglia per la precisione.
𝑷𝒐𝒕𝒓𝒆𝒎𝒎𝒐 𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒍𝒐 𝒂 𝒕𝒓𝒐𝒗𝒂𝒓𝒆!...𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒂𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒎𝒊 𝒑𝒊𝒂𝒄𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐? 𝑨𝒔𝒄𝒐𝒍𝒕𝒆𝒓𝒐̀ 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒈𝒍𝒊 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒎𝒊 𝒉𝒂𝒊 𝒆𝒍𝒆𝒏𝒄𝒂𝒕𝒐
E ce ne sono altri. Comunque vedrai che sarà ogni volta come entrare in un posto conosciuto ma mai uguale a se stesso e scoprirai che i colori sono tanti.
𝑺𝒂𝒊, 𝒏𝒐𝒕𝒐 𝒂𝒅𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒕𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒍𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒊, 𝒅𝒊 𝒗𝒊𝒃𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒕𝒊𝒎𝒐𝒍𝒂𝒏𝒐 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂, 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒂𝒗𝒓𝒆𝒎𝒎𝒐 𝒅𝒐𝒗𝒖𝒕𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊 𝒗𝒊𝒃𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒕𝒊𝒎𝒐𝒍𝒂𝒏𝒐 𝒍’𝒖𝒅𝒊𝒕𝒐.
Cosa importa? Tutto è collegato in qualche modo: i sensi, l’intelletto: basta sapere ascoltare.
𝑊ℎ𝑎𝑡'𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑘𝑦 𝑛𝑜𝑤?
𝑇𝑒𝑎𝑝𝑜𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑐𝑎𝑛 𝑓𝑙𝑦 𝑛𝑜𝑤
𝑉𝑜𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑒𝑎𝑑
𝑇𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑒 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑠𝑎𝑖𝑑
(𝐺𝑜𝑛𝑔 - 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐺𝑛𝑜𝑚𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒)
foto e articolo di © Roberto Gaudenzi - 16 ottobre 2020

𝐂𝐀𝐍𝐓𝐄𝐑𝐁𝐔𝐑𝐘 𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚
𝐿𝑖𝑓𝑒`𝑠 𝑡𝑜𝑜 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑠𝑎𝑑, 𝑤𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑦𝑜𝑢'𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑣𝑒
𝑌𝑜𝑢'𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑓𝑓 𝑛𝑜𝑡 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒
𝐷𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑜 𝑠𝑜𝑜𝑛
𝑆𝑜𝑢𝑛𝑑𝑠 𝑜𝑓 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑜𝑑𝑦, 𝑜𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑑, 𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 ...
(𝐶𝑎𝑟𝑎𝑣𝑎𝑛 - 𝑊𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑖𝑛𝑒)
𝑩𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒆𝒔𝒂, 𝒅𝒐𝒗𝒆 𝒎𝒊 𝒉𝒂𝒊 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒕𝒐?
Guarda che non è una semplice chiesa, è una cattedrale, la cattedrale di 𝐂𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐛𝐮𝐫𝐲.
𝑨𝒉, 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒊 𝒓𝒂𝒄𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒂𝒏𝒏𝒊 𝒇𝒂?
Bravo, proprio quella. Ma non siamo qui per parlare di letteratura, non solo di quella perlomeno. I pellegrini dei racconti che hai ricordato si ritrovano tutti in una locanda e in fondo anche queste storie iniziano non da una locanda ma da una casa da qualche parte qui a sud-est dell’Inghilterra.
𝑪𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒂𝒍𝒕𝒓𝒊 𝒑𝒆𝒍𝒍𝒆𝒈𝒓𝒊𝒏𝒊?
Bè, in un certo senso sì, solo che anziché raccontarsi storie edificanti, viaggeranno armati di strumenti musicali.
𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄𝒊𝒔𝒕𝒊...
Ecco, parte tutto da Wellington House.
𝑪𝒉𝒊 𝒆̀ 𝒒𝒖𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒐𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛𝒛𝒊𝒏𝒂?
Quello è il figlio dei proprietari di questa casa, è così per un incidente di gioventù, è stato il “batterista bipede” così lui si definisce.
𝑨𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊, 𝒑𝒐𝒗𝒆𝒓𝒆𝒕𝒕𝒐, 𝒃𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒍’𝒖𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒈𝒂𝒎𝒃𝒆!
Ma lui suona di tutto, non era limitato ad un solo strumento, e comunque ne aveva uno che era inconfondibile: la voce. Intorno a lui e in questa casa si sono trovati molti amici nei primi anni ’60, sai? I pellegrini che hanno iniziato questo itinerario, senza sapere di averlo tracciato però.
𝑮𝒊𝒂̀, 𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒔𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒗𝒗𝒊𝒔𝒂𝒕𝒆 𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒆 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒄𝒐𝒏𝒐 𝒎𝒆𝒈𝒍𝒊𝒐. 𝑴𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒔𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒂𝒎𝒂?
𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐖𝐲𝐚𝐭𝐭, e c’era un amico di scuola con lui un tale 𝐇𝐮𝐠𝐡 𝐇𝐨𝐩𝐩𝐞𝐫 che suonava il basso.
𝑴𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒆𝒉? 𝑵𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒍𝒊 𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒕𝒐.
Eh sì, nel 2009. Lui Wyatt e 𝐌𝐢𝐤𝐞 𝐑𝐚𝐭𝐥𝐞𝐝𝐠𝐞 formeranno i 𝐒𝐨𝐟𝐭 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞.
...𝑵𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒊𝒍 𝒕𝒊𝒕𝒐𝒍𝒐 𝒅𝒊 𝒖𝒏 𝒓𝒐𝒎𝒂𝒏𝒛𝒐 𝒅𝒊...𝒂𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒎𝒊 𝒗𝒊𝒆𝒏𝒆...
𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦 𝐁𝐮𝐫𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡𝐬! Vedi che la letteratura in qualche modo c’entra? Ma c’era un altro con loro si chiamava 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐀𝐲𝐞𝐫𝐬, era un chitarrista e avrebbe dovuto esserci un altro ancora...ecco vedi quello vestito da mago Merlino?
𝑺𝒊̀, 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒄𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒐!
Certo, sai di quelli un poco pazzi, senza i quali forse alcune cose sarebbero un poco noiose, arrivava dall’Australia si chiamava 𝐃𝐚𝐞𝐯𝐢𝐝 𝐀𝐥𝐥𝐞𝐧, per una storia di passaporto non è arrivato in tempo quando la Macchina Morbida si è formata ma lui non si è scoraggiato e ha fondato i 𝐆𝐨𝐧𝐠...
𝑴𝒐𝒓𝒕𝒊 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒐𝒓𝒐 𝒆𝒉?...𝑴𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒓𝒂𝒛𝒛𝒂 𝒅𝒊 𝒅𝒓𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒊 𝒔𝒕𝒂 𝒈𝒊𝒓𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒖𝒍𝒍𝒂 𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂?
...Oh, quello! non è un drone è una Teiera Volante, arriva da un altro pianeta: il pianeta Gong appunto, da lì trasmette Radio Gnome Invisible.
𝑪𝒊 𝒎𝒂𝒏𝒄𝒂𝒏𝒐 𝒑𝒖𝒓𝒆 𝒈𝒍𝒊 𝒂𝒍𝒊𝒆𝒏𝒊.
Ma non sono gli omini verdi, sono i 𝑅𝑒𝑑 𝐻𝑜𝑡 𝑃𝑖𝑥𝑖𝑒𝑠, forse Allen era uno di loro, un extraterrestre appunto.
𝑬𝒓𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒕𝒕𝒐𝒓𝒆-𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒂?
No ma vedi, come lui era un poco stralunato: non devi appartenere del tutto a questa Terra se vuoi uscire dal seminato e in quella casa un poco alieni lo erano.
𝑴𝒂 𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒈𝒊𝒂𝒓𝒅𝒊𝒏𝒐 𝒉𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂 𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒇𝒊𝒐𝒓𝒊!
Vedi, hanno lasciato tracce variopinte, prima di 𝑆𝑜𝑓𝑡 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 si chiamavano 𝐖𝐢𝐥𝐝 𝐅𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬, Fiori Selvaggi, hanno seminato proprio qui e ancora i loro semi fioriscono, e fioriscono proprio in Italia anche se sono conosciuti da una nicchia di persone, ti cito i 𝐖𝐢𝐬𝐭𝐨𝐧𝐬 𝐢 𝐌𝐨𝐨𝐠𝐠, 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐙𝐮𝐟𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢 solista, gli 𝐇𝐨𝐦𝐮𝐧𝐜𝐮𝐥𝐮𝐬 𝐑𝐞𝐱...solo per dirne alcuni.
.𝑴𝒂𝒊 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕𝒊 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒆.
Non mi stupisce e magari fra cent’anni nessuno più li conoscerà, succede in tutti i campi. Nella musica conosciamo tutti Beethoven, Mozart e pochi altri, ma esiste un lungo corteo di musicisti che solo gli appassionati o gli esperti conoscono, così sarà per loro...forse, o forse no. Comunque per tornare a noi, non tutto è un idillio come sai e dopo quattro album i Soft Machine, in maniera non molto soft per la verità, allontanano Wyatt, e diventeranno un gruppo un poco differente, ma sempre qui sarà il loro sguardo.
𝑨𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊, 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒓𝒊𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒔𝒄𝒂𝒄𝒄𝒊𝒂𝒕𝒐, 𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆́ 𝒎𝒂𝒊?
Divergenze musicali, non accettavano più il suo modo di cantare, sì, lui si sentirà tradito ma formerà subito una sua band e la battezzerà Matching Mole, storpiando il nome con il francese 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐞, Macchina Morbida e mole è anche la talpa, animale che vive sotto terra.
𝑬 𝒂𝒍𝒍’𝒆𝒑𝒐𝒄𝒂 𝒔𝒖𝒐𝒏𝒂𝒗𝒂 𝒂𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒃𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂?
Certo, l’incidente sarebbe successo di lì a poco. Ma vieni facciamo un giro attorno alla casa. Questo è successo durante tutti o quasi gli anni ’60 e per buona parte dei ’70: scorrevano tante cose nel mondo, stava cambiando molto ed è stato come se loro avessero cavalcato il cambiamento a modo loro, intendo tutti gli artisti che intorno a questa cittadina hanno orbitato, e chi a questo sound si ispirava: cambiavano a modo loro, prendi questi che stiamo ascoltando...li senti?
𝑺𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒏𝒊, 𝒔𝒊̀.
Si chiamano 𝐄𝐠𝐠 prima erano gli 𝐔𝐫𝐢𝐞𝐥 e purtroppo non ci hanno lasciato nulla in eredità. Sono poi diventati gli 𝐀𝐫𝐳𝐚𝐜𝐡𝐞𝐥 sono entrati in studio e hanno inciso un unico disco folle, solo quello, poi il chitarrista 𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐇𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 se ne è andato e sono rimasti in tre... Perché ti fermi?
𝑨𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊, 𝒎𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒗𝒆𝒅𝒊? 𝑬’ 𝒖𝒏 𝒑𝒂𝒆𝒔𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒏𝒐....𝒃𝒆𝒍𝒍𝒊𝒔𝒔𝒊𝒎𝒐, 𝒒𝒖𝒊 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂 𝒅𝒐𝒑𝒐 𝒑𝒐𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒊...𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒊! 𝑬’ 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒈𝒓𝒊𝒈𝒊𝒐 𝒆 𝒓𝒐𝒔𝒂...
Benvenuto nella 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐫𝐢𝐠𝐢𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐨𝐬𝐚.
𝑵𝒐𝒏 𝒎𝒊 𝒔𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂𝒏𝒐 𝒈𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒆𝒔𝒔𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒕𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒂𝒔𝒄𝒐𝒍𝒕𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒊...𝒑𝒆𝒓𝒐̀ 𝒑𝒐𝒕𝒓𝒆𝒃𝒃𝒆𝒓𝒐 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆.
No, non sono gli 𝐄𝐠𝐠, loro senti? sono più rarefatti, sciolgono i suoni in ondate quasi psichedeliche, potrebbero creare macchie di colore, spruzzi variopinti, no questi sono...eccoli, li vedi laggiù?
𝑽𝒆𝒅𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒖𝒏 𝒇𝒖𝒓𝒈𝒐𝒏𝒆, 𝒏𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒔𝒆 𝒆̀ 𝒖𝒏 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒆𝒓.
Un camper, e loro sono sopra, si chiamano 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐯𝐚𝐧, appunto.
𝑴𝒊 𝒔𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂 𝒒𝒖𝒂𝒔𝒊 𝒅𝒊 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆...𝒉𝒂𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒍 𝒇𝒊𝒍𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑹𝒐𝒃𝒊𝒏 𝑾𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒎𝒔? 𝑨𝒍 𝒅𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒅𝒆𝒊 𝒔𝒐𝒈𝒏𝒊.
Bravo, hai ragione, i colori però qui sono tenui, pastellati.
𝑬’ 𝒖𝒏 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒃𝒊𝒄𝒓𝒐𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒐.
Vero, ma sai quante sfumature di grigio esistono?...Non alludo al libro non guardarmi così...e quante sfumature di rosa, il rosa è un colore che può crescere nel rosso. I Caravan hanno pennellato gradazioni diverse di queste due tinte: il rosa che è leggero, mi viene da dire femminile ma per parità di genere non lo dirò, ma può variare nel carminio che è rosso scarlatto, o impallidirsi fino quasi al bianco e qui può incontrare il grigio pallido, può scurirsi. Il grigio non è tanto un colore quanto un variare della luce, la luce che smette di essere respinta totalmente e restituisce sfumature sempre più scure, viene assorbita, fino al nero ma i Caravan non arrivano mai a questo limite, nessuno di loro “canterburyani” arriva mai a questo limite: una certa leggerezza e ironia surreale che non è mai risata sguaiata, e una certa malinconica tristezza che non è mai disperazione o visione negativa.
𝑴𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒐𝒓𝒆 𝒍𝒂𝒈𝒈𝒊𝒖̀ 𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛𝒛𝒆𝒍𝒍𝒂? 𝑵𝒐𝒏 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒐 𝒔𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒔𝒊̀ 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒐 “𝒍𝒆𝒈𝒈𝒆𝒓𝒐”!
Ti sbagli, lui è simbolo di tenacia e di adattamento alle circostanze, di cambiamento. Certamente ha avuto i suoi momenti neri, e li avrà tutt’ora. Lui è sempre stato attivo musicalmente e comunque una certa dose di ironia non lo ha mai abbandonato e la sua musica non è mai stata “dogmatica”.
𝑫𝒐𝒈𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂, 𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒐𝒍𝒐𝒏𝒂! 𝑻𝒊 𝒔𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂 𝒔𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒂 𝒖𝒔𝒂𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂?
Sì, hai ragione, non è pertinente, ma mi è venuta in mente un’orchestra che esegue un brano scritto: è guidata da un direttore che dal podio la dirige, ogni strumentista deve fare quello che lui esige si faccia, ogni musicista deve conformarsi alla sua interpretazione, tra questi musicisti non funziona così, non in modo così rigido per lo meno: qui può esserci un via vai e ognuno porta con sé la propria interpretazione.
𝑴𝒂... 𝒗𝒆𝒅𝒐 𝒍𝒂𝒈𝒈𝒊𝒖̀ 𝒅𝒆𝒊 𝒄𝒂𝒎𝒎𝒆𝒍𝒍𝒊, 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒖𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒕𝒐... 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂?
E’ il loro simbolo sono i 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐥, non sono di Canterbury ma è come se lo fossero, lo spirito è quello. Si sono ispirati per il loro terzo album ad un romanzo di uno scrittore americano 𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐢𝐜𝐨, nell’album precedente, 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐠𝐞, si sono ispirati in parte a 𝐼𝑙 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝐴𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖...vedi che la letteratura c’entra ancora?
𝑷𝒆𝒓𝒐̀, 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒗𝒆𝒓𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒊𝒄𝒄𝒉𝒊 𝒅𝒊 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒊𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 “𝒄𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒃𝒖𝒓𝒚𝒂𝒏𝒊”! 𝑺𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒏𝒆𝒍 𝒃𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒛𝒛𝒐 𝒅𝒊 𝒖𝒏𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂 𝒈𝒓𝒊𝒈𝒊𝒂 𝒆 𝒓𝒐𝒔𝒂, 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒊𝒍 𝒄𝒊𝒆𝒍𝒐 𝒆̀ 𝒓𝒐𝒔𝒂, 𝒄𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒆𝒕𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒊𝒍 𝒕𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒂 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒂 𝒆 𝒍𝒆 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒈𝒏𝒆 𝒍𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒐; 𝒔𝒐𝒑𝒓𝒂 𝒅𝒊 𝒏𝒐𝒊 𝒗𝒐𝒍𝒂𝒏𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒆𝒊𝒆𝒓𝒆 𝒆 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒐 𝒈𝒏𝒐𝒎𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒎𝒆𝒕𝒕𝒆; 𝒄’𝒆̀ 𝒖𝒏 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒆𝒓 𝒆 𝒄𝒂𝒎𝒎𝒆𝒍𝒍𝒊...𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒐𝒓𝒆 𝒃𝒂𝒓𝒃𝒖𝒕𝒐 𝒔𝒖𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛𝒛𝒊𝒏𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒖𝒍 𝒑𝒐𝒏𝒕𝒊𝒍𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒊 𝒂𝒍𝒍𝒖𝒏𝒈𝒂 𝒏𝒆𝒍 𝒍𝒂𝒈𝒉𝒆𝒕𝒕𝒐: 𝒎𝒂 𝒄𝒐𝒔𝒂 𝒈𝒍𝒊 𝒆̀ 𝒎𝒂𝒊 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒐?
Seguimi, ce lo faremo raccontare da lui.
foto e articolo di © Roberto Gaudenzi - 9 ottobre 2020
(Continua nella prossima SmaniaRock)

PARANOID
Black Sabbath (1970)
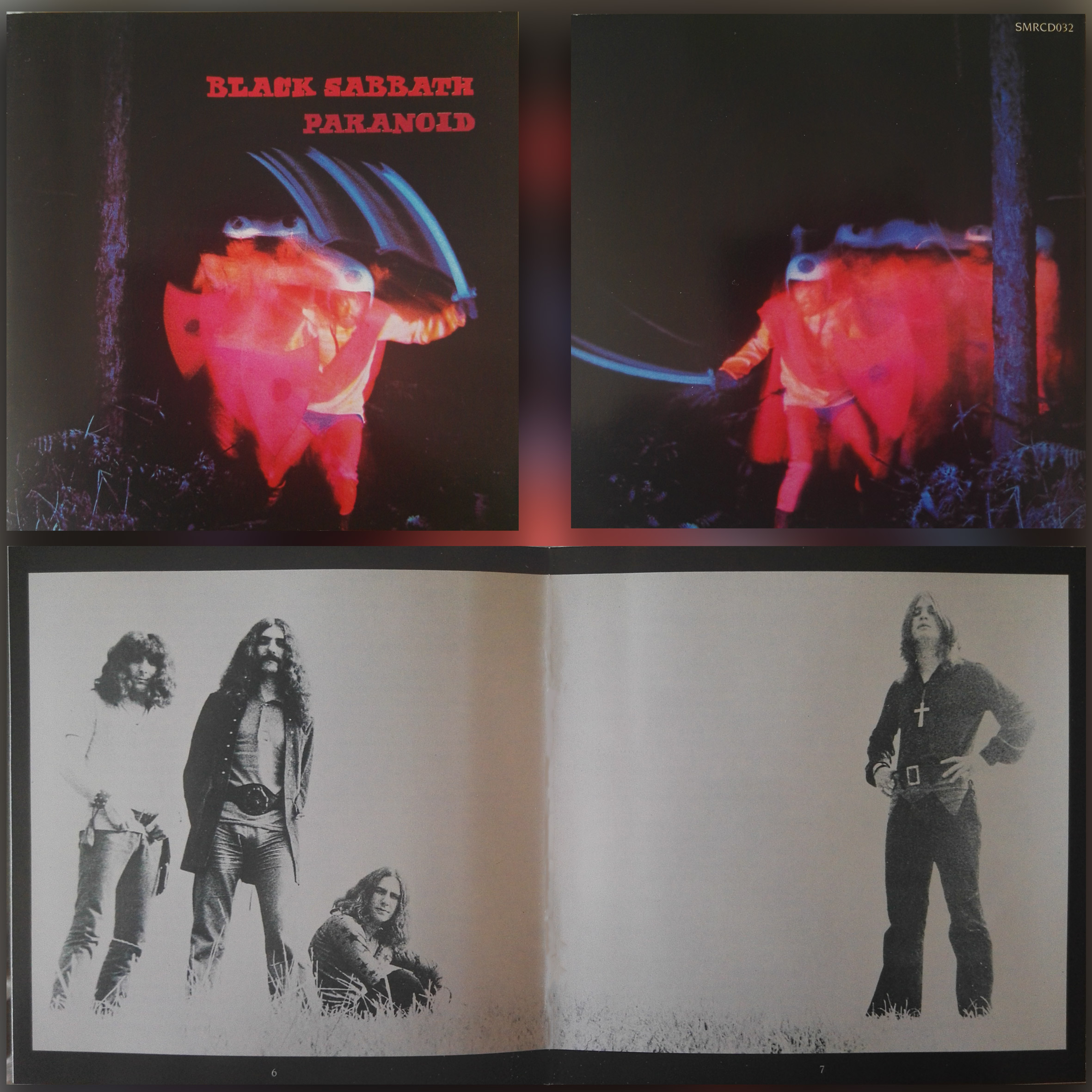
𝐁𝐋𝐎𝐖𝐒 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍𝐒𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐌𝐏𝐈𝐑𝐄
𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐊𝐚𝐧𝐭𝐧𝐞𝐫 (1970)

𝐂𝐎𝐒𝐌𝐎'𝐒 𝐅𝐀𝐂𝐓𝐎𝐑𝐘
𝐂𝐫𝐞𝐞𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐫𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐯𝐚𝐥 (1970)

𝐀𝐁𝐁𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐈 𝐔𝐍 𝐁𝐋𝐔𝐄𝐒 𝐃𝐀 𝐏𝐈𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑𝐄
Perigeo (1973)

𝐀𝐑𝐁𝐄𝐈𝐓 𝐌𝐀𝐂𝐇𝐓 𝐅𝐑𝐄𝐈
AREA (1973)

𝐇𝐀𝐍𝐃.𝐂𝐀𝐍𝐍𝐎𝐓.𝐄𝐑𝐀𝐒𝐄
𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐖𝐢𝐥𝐬𝐨𝐧 (2015)

SEVENTEEN SECONDS
THE CURE (1980)

ASTROLABIO
Garybaldi (1973)

𝐋𝐀 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂𝐀 𝐂𝐇𝐄 𝐒𝐔𝐎𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎
𝐐𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐋𝐄 𝐋𝐔𝐂𝐈 𝐒𝐈 𝐑𝐈𝐀𝐂𝐂𝐄𝐍𝐃𝐎𝐍𝐎
Omaggio a Ennio Morricone

𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐓 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐒𝐎𝐍 𝐊𝐈𝐍𝐆
(𝐀𝐧 𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐲 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨)
𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐫𝐢𝐦𝐬𝐨𝐧 (𝟏𝟗𝟔𝟗)

WITH THE BEATLES AND OTHER STORIES
THE BEATLES (1963)

UMMAGUMMA
PINK FLOYD (1969)

𝐈𝐅 𝐈 𝐂𝐎𝐔𝐋𝐃 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐑𝐄𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐌𝐘 𝐍𝐀𝐌𝐄
DAVID CROSBY (1971)
Curioso che il “sogno” abbia avuto il suo apice in occidente e il suo epilogo in oriente.
La California è terra di confine, meta finale degli antichi pionieri che hanno riempito dei propri sogni non solo il continente nord americano ma anche buona parte dell’”Occidente” che di quel sogno si nutriva. In prossimità della costa orientale si consuma il “sogno” in quella che diventerà una grande festa.
Il lato dove il sole sorge è l’epilogo di qualcosa nato in occidente in un curioso scambio di metafore che sembra voler chiudere un cerchio.
𝐈𝐟 𝐈 𝐂𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐌𝐲 𝐍𝐚𝐦𝐞
Se potessi ricordare come mi chiamo...
lascia dei puntini di sospensione che annunciano una volontà che non sa arrendersi. Una perdita di identità, una smemoratezza e quel condizionale che sembra richiamare uno sforzo, un rammarico per qualcosa che si è abbandonato.
La copertina dell’album mostra il volto di Crosby sovrapposto a un tramonto sul mare: la linea dell’orizzonte taglia il viso sotto agli occhi e il sole è la goccia di una lacrima.
Il mare dunque, e un orizzonte vuoto.
Dal canale sinistro una chitarra emerge come un suono che dura da tempo, cresce e occupa lo spazio, poche pennate e un accompagnamento di tablas colorato dal basso per dire che
“𝐿𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑒̀ 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑒, 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑒̀ 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑒”,
𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐢𝐬 𝐥𝐨𝐯𝐞. Il canto è corale, universale, e crederci fino in fondo significa affermare una certezza, che forse rimarrà unica.
“𝐼𝑛𝑑𝑜𝑠𝑠𝑎 𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖, 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑖 𝑎 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒
𝑇𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑒̀ 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠
𝑇𝑜𝑔𝑙𝑖𝑡𝑖 𝑖 𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖 𝑒 𝑠𝑑𝑟𝑎𝑖𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑒
𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑒̀ 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜.”
La musica salva perché ti mette a nudo e fa risplendere la tua vera natura: se hai dimenticato il tuo nome, il modo per ritrovare la strada verso la tua identità passa dalla musica che è libera ed è divertente. Una componente ludica che è una ricerca di senso e in definitiva di sé.
La dichiarazione di intenti è quindi chiara: oltre i puntini di sospensione c’è la musica che si annuncia con poche battute e con frasi ripetute, in uno stile quasi tribale, uno stile che fa della spontaneità la sua cifra distintiva. Quindi con questo incipit si può affermare che la musica è la base di partenza per una ricerca, per una identificazione tra il sé e l’oltre: il volto della copertina e il mare, due cose in una, un’assimilazione ancora in divenire che fa leggere il sole sopra l’orizzonte non solo come un tramonto ma anche come un’alba.
Come un film western, dove ogni personaggio è solo di fronte a una natura selvaggia, dove ognuno è senza filtri e la legge non può intervenire, dove in definitiva si manifesta la vera natura di ognuno, e ognuno è di fronte al proprio io. 𝐂𝐨𝐰𝐛𝐨𝐲 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞, elettrica e nervosa, singhiozzante, dove le chitarre lacerano come colpi di pistola, schioppettate in faccia ad un equivoco: un’indiana che tutti vorrebbero dalla propria parte, si rivela essere la legge. Il cantato di Crosby è un crescendo che declama l’impossibilità di imbrigliare la legge, il suo essere desiderabile ma irriducibile. Il nome dimenticato qui sembra ritrovare un’onomastica, ogni personaggio ha un nome, il film della vita ci fa soggiacere a leggi che stanno sopra di noi. L’andatura del brano, con una ritmica ossessiva e la chitarra solista di Garcia che interviene di taglio, acida, ora urlante ora poco più suadente, incide nella canzone in modo bruciante.
𝐓𝐚𝐦𝐚𝐥𝐩𝐚𝐢𝐬 𝐇𝐢𝐠𝐡 (𝐀𝐭 𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 𝟑) gioca forse sull’ambiguità: sarà la vetta, muta, dalla quale contemplare il mare, il confine ultimo, in un isolamento senza parole? Oppure sarà la High School con lo stesso nome? E perché At About 3? Circa le tre del pomeriggio o circa le 3 del mattino? Il brano è senza parole come la 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐧𝐨 𝐖𝐨𝐫𝐝𝐬 (𝐓𝐫𝐞𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐧𝐨 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐬), entrambi con una parentetica nel titolo che suggerisce una contemporaneità, nel primo caso, e uno spostamento di senso nel secondo, e come senza parole è il breve brano cantato a cappella che chiude l’album: 𝐈’𝐝 𝐬𝐰𝐞𝐚𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐡𝐞𝐫𝐞, (Giuro che c’era qualcuno qui), con la voce che si perde in un richiamo, un urlo a cui risponde il silenzio.
La canzone senza parole, un ossimoro: una canzone è fatta di parole, la canzone nasce soprattutto come componimento poetico successivamente musicato, ma se un “albero senza foglie” mantiene comunque il proprio statuto di albero, una canzone muta non è più tale, perde il proprio stato: diventa silenzio, stante il significato originario, o si tramuta in un vocalizzo, in uno scat dove la voce torna ad essere suono puro, modulazione di note, quindi musica.
La musica dunque che precede il linguaggio, che lo trascende e lo anticipa. La canzone ha perso le parole come l’albero perde le foglie, non rimane niente altro da dire anche se “giurerei che qui c’era qualcuno,” che l’urlo di una generazione non finisca nella solitudine del vuoto, nello smarrimento dell’ultimo canto che risuona in una serie di echi.
Talmapais Hight è dunque la montagna intesa come luogo di sfida con se stessi, come vetta da raggiungere nella ricerca muta del proprio essere o nell’altra accezione come scuola, come luogo di apprendimento per eccellenza e nel suo essere senza parole rivela una ricerca di significato; Song with no words al pari di un albero si spoglia delle foglie nel tentativo di rigenerarsi, si scarica di un fardello rinsecchito nell’attesa della rinascita di nuovi germogli.
𝐋𝐚𝐮𝐠𝐡𝐢𝐧𝐠 è l’equivoco, la parola sbagliata, il fraintendimento.
Qui la canzone recupera le parole, certo, ma per negarne quasi la loro utilità.
𝑰 𝒘𝒂𝒔 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒂𝒌𝒆𝒏,
canta Crosby come ritornello sospendendo ogni suono, seguono due note che sottolineano il rammarico: mi sono sbagliato, nessuno sa cosa sta succedendo, colui con cui parlo è solo un altro sconosciuto. C’è un’illusione che percorre il brano, che lo alimenta e lo infarcisce di speranza: Pensavo, dice, nel significato di credevo, mi ero illuso, non era la luce che poteva guidare attraverso tutta questa oscurità erano solo i riflessi di un’ombra. Anche qui si manifesta un bellissimo ossimoro dove un’ombra, quindi un’oscurità per definizione, manda dei riflessi: impossibilità fisica come poter vedere attraverso l’oscurità. La musica si articola come in buona parte dell’album per suggerimenti, note isolate nel contesto ritmico, a prevalere è la chitarra solista che sembra lamentarsi lanciandosi in note sovente lancinanti, lamentevoli, colorando l’atmosfera con la slide. Pensavo di avere trovato qualcuno che mi portasse fuori da questa oscurità, qualcuno che conosceva la verità....mi sono sbagliato era solo la risata di un bambino.
Il riso liberatorio non esce dalla gola di un adulto, che avrebbe potuto conferire al testo un tono amaro o sarcastico, ma è un bambino a ridere con l’ingenuità che un riso infantile può richiamare. Di fronte a interrogativi esistenziali risponde l’allegria di un bambino che lascia spazio alla lunga chiusa della chitarra con la ritmica che accentua la parte cupa del testo, come un richiamo costante all’errore mentre la sei corde lamenta la mancanza di risposte in un intervento struggente, un tema, un riff in minore che cala, discende fino a spegnersi nella dissolvenza.
𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬 nasce dallo sconcerto, due note di chitarra come un punto interrogativo, la ricerca del tema, un sovrapporsi di arpeggi, note isolate, temi, ricami, mentre il bordone iniziale fa da sottofondo il brano cresce poco alla volta, cresce in dissolvenza, con note isolate che sembrano cercare una strada, forse un pezzo che andrebbe posto ad inizio album: chi sono le persone che ci guidano? Chi ha in mano le sorti della nazione? La melodia si costruisce come una domanda che si formula mano a mano, la batteria che entra con un leggero rullare, il tempo definito come una vampa di luce dal fondo di una oscurità, sorregge il tema.
𝐓𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐢𝐧 racchiude un mistero, forse un enigma da risolvere, magari un testo non-sense.
E’ abbastanza difficile trovare la forza di tornare dove tutto è cominciato tornare bambini forse o ricominciare da capo. Si accenna a un nuovo diluvio universale (trascinarsi nella pioggia): vi sono una tortora e una colomba con un ramo d’ulivo, certo è che questi rimandi biblici, religiosi, vengono ripresi in 𝐎𝐫𝐥𝐞𝐚𝐧𝐬 brano tradizionale francese dove vengono citati nomi di cattedrali, come si volesse recuperare una forma di religiosità che conduce a una confusione, a frasi prive di senso immediato così come lo è privo di utilità e di senso un ritorno alla religione dei padri. Il già citato 𝐈’𝐝 𝐬𝐰𝐞𝐚𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐡𝐞𝐫𝐞, here, infatti lascia senza fiato nella sua brevissima misura: improvvisato a cappella, il brano lancia voci e echi che riverberano tra pareti vuote, vibrano su corde vocali anche qui senza parole.



